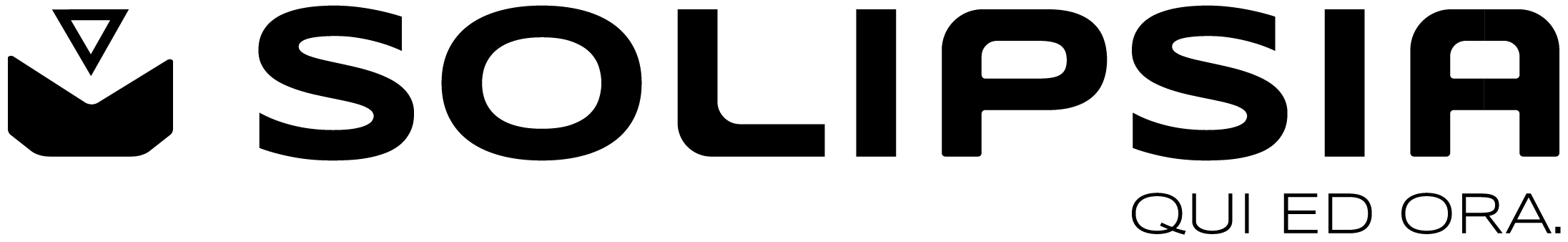«Everything has beauty but not everyone can see it» recita uno dei tanti graffiti che popolano i muri di Melbourne, Australia. Everything, ma proprio everything. Persino la distruzione e il decadimento hanno sempre generato un grande fascino tra le menti più sensibili, basti citare uno dei periodi artistici di maggiore interesse nel corso della storia (e attuale ancora oggi) noto come Decadentismo. Nella sua critica della morale borghese, la generazione dei poeti maledetti decanta la propria malinconia e la propria sofferenza nei confronti della società contemporanea; allo stesso modo Edvard Munch dipinge una sagoma, un’ombra, che cammina in direzione contraria rispetto alla folla benpensante che popola la Sera nel Corso Karl Johann. La sensazione alla base delle due iniziative è quella di un disfacimento totale del pre-costituito e quindi del substrato ideologico che lo supporta, cercando il nuovo, il vero, l’altrove per dirla con le parole di Basquiat, citato integralmente alla fine di questo scritto. Tuttavia, questi artisti si sono scontrati inesorabilmente e senza successo con quei tipi di perversione sociale che descrivono così abilmente nelle loro opere, tanto che il loro sentimento di distruzione è stato facilmente emarginato e trasformato così in autodistruzione, distruzione del sé.
Ma cos’è che tocca così a fondo la sensibilità di artisti e pensatori? Sicuramente il potere catartico della distruzione, che essa condivide con l’arte. Quando qualcosa crolla significa che molto altro può essere costruito/creato. Paradossalmente, la smania di costruire nasce proprio dalla volontà di abbattere. Per dirla alla Pablo Picasso: «Ogni atto di creazione è, prima di tutto, un atto di distruzione». Come in ogni fenomeno umano, capita spesso che questa distruzione (e la conseguente costruzione) non sia davvero costruttiva: ne sono un esempio lampante le guerre, che riducono intere popolazioni nella miseria al fine di ottenere e/o preservare un dominio politico, economico, geografico. Ma anche in questo caso, seppure prevalga una volontà negativa, prevale pur sempre quella forza di volontà tanto cara a Nietzsche, la quale dovrebbe essere fautrice di cambiamento, quindi di costruzione. Peccato (o per fortuna, letterariamente parlando) che il filosofo tedesco sia piombato nel suo proverbiale nichilismo, facendo seguire alla seppur condivisibile provocazione «Dio è morto» una sfiducia esistenziale e pressoché totale verso la vita. Anche in questo caso ha prevalso l’autodistruzione.
L’inversione di tendenza avviene quando qualcuno si accorge che il disfacimento è il motore scatenante della creazione. Uno dei movimenti artistici (perché diciamo già da subito che di arte si tratta, qualcosa di più e non qualcosa di meno) e sociali dell’ultimo secolo che percepisce e coglie questa possibilità è il writing (o graffitismo, per i puristi della lingua). Nato a Philadelphia negli anni ’60, il Graffiti Writing prende origine da una parte della società costantemente emarginata, tenuta fuori dalle dinamiche borghesi del centro città e, per questo, privata di ogni possibilità. Questo contesto di ghettizzazione riversa i ragazzi per strada alla ricerca di un riscatto sociale che si esprime attraverso varie forme artistiche, tutte sostenute dalla medesima voglia di scandire il proprio nome e comunicare un messaggio che, altrimenti, rimarrebbe inascoltato. Sempre in quegli anni, l’arte assume una posizione ancora più commerciale e commercializzata, come conseguenza del suo statuto di Popular (Pop), alimentando una forma elitaria di distribuzione. Questo aumenta il divario sociale e genera di fatto una scissione nel mondo dell’arte, che esploderà negli anni avvenire con la polarizzazione in mainstream e underground. Ma se è vero che il primo non è un movimento popolare, ma la naturale conseguenza dei mass-media (quindi un movimento indiretto), il secondo prende voce proprio dal disagio popolare dovuto al confinamento sociale. La distruzione della periferia è imposta dall’esterno e spesso si traduce in una forma di razzismo e discriminazione -oltre che in una seria carenza strutturale- dovuta all’oscurantismo e all’ignoranza dei più. Il writer è una delle prime figure che decide di non sottostare alla distruzione: piuttosto, utilizza quegli stessi muri fatiscenti e quelle colate di cemento per comunicare il proprio dissenso, esprimere la propria ribellione e riqualificare di proprio pugno quella realtà periferica che qualcuno vorrebbe distrutta, degradata, abbandonata, ma per altri rappresenta casa (home, casa a cui appartengo, non house, abitazione).
Gli stessi anni ’60 rappresentano per l’Italia il periodo del boom economico, quello della smisurata fiducia verso il denaro e gli investimenti, sia da parte dei privati che del pubblico. L’industria prende il posto delle campagne e le città si espandono sempre di più, aumentando il proprio raggio d’influenza. La mole di costruzioni erette in questa decade è impressionante e genera un fenomeno endemico di abusivismo e corruzione, oltre che inquinamento della natura. Gli strascichi di questa urbanizzazione intensiva sono osservabili al giorno d’oggi, poichè il territorio nazionale è costellato di edifici abbandonati e/o inutilizzati ed il cemento ha preso il posto delle piante. In linguaggio giornalistico, si parla di ecomostri: edifici incompatibili con l’ambiente circostante, che non adempiono ad alcuna funzione specifica perché obsoleti o incompleti.
Questa definizione, usata oggi con regolarità, è stata utilizzata per la prima volta da Legambiente in riferimento all’Hotel Fuenti -a Vietri sul Mare, in provincia di Salerno- il primo ecomostro della storia ad essere abbattuto nel 2004. La struttura è stata soggetta a numerosi processi in tribunale che ne mettevano in dubbio l’impatto ambientale, venendo questa a nascere sulla scogliera protetta della costiera amalfitana. Tra le varie storie di abusivismo edilizio va menzionata anche la collina del disonore, a Palermo: una serie di villette costruite dalla mafia e rimaste incompiute, che tutt’oggi dominano il paesaggio che affaccia sul golfo di Mondello.
D’altronde, i casi sono innumerevoli, dall’abusivismo… alla Chiesa. Tra le costruzioni erette in quegli anni, ce n’è una a Casalecchio di Reno -a due passi da Bologna- molto imponente e allo stesso tempo raffinata, il cui progetto architettonico, firmato da Glauco Gresleri, Nevio Parmeggiani e Umberto Daini e ispirato alla scuola di Le Corbusier, la rende tutt’oggi un oggetto di studio per gli apprendisti architetti. Con i suoi sei livelli d’altezza che dominano lo scenario naturale dell’appennino, questa struttura fu commissionata dai Padri Passionisti, un gruppo di monaci intenzionato a costruire degli alloggi per orfani (secondo alcuni) o un seminario per nuovi adepti (secondo altri). Ad ogni modo, il Mostro di Casalecchio non è mai stato nulla di tutto ciò. A riguardo, molti giornali, tra cui l’autorevole rivista National Geographic, riportano che questo edificio non è mai entrato in funzione a causa di una “crisi delle vocazioni”, ma in realtà lo stesso architetto Gresleri, nel 2013, ha dichiarato a il Resto del Carlino che la cessazione dei lavori avvenne “perché i Passionisti cambiarono idea”.
Una locuzione utilizzata spesso per riferirsi ad edifici di questo tipo è quella di cattedrale nel deserto. Casualità?
Sta di fatto che, da sessant’anni a questa parte, il Mostro rappresenta un esempio lampante di spreco edilizio, abuso della natura e cattiva gestione della proprietà. Quest’ultima, oltretutto, è passata attraverso vari enti ed aziende (attualmente la società Eremo srl) che non sono riuscite né a darle una vita nuova né a portare avanti un dialogo con il comune di Casalecchio: a testimonianza di come la logica speculativa che regola i rapporti tra pubblico e privato abbia portato, anche in questo caso, ad una fase perenne di stallo. L’unica possibilità paventata, per altro agognata dai più, resta quella dell’abbattimento.
Tuttavia, a partire da questo stato di distruzione strutturale e degradazione burocratica, è nato qualcosa di bello. Mentre le istituzioni parlano di abbattere, qualcuno ne approfitta per creare. Ad oggi, il Mostro di Casalecchio è uno spettacolo a cielo aperto, anzi, a tutti gli effetti un museo a cielo aperto. Numerosi artisti, locali e non, sono accorsi presso questa struttura a partire dagli anni ’60 (e ancora oggi) per lasciare un tag, una scritta, un disegno su quelle pareti fatiscenti. I writer hanno tinto di colore una struttura grigia e decadente e hanno realizzato dei pezzi unici, in quanto molte di queste opere sono realizzate appositamente su un determinato diroccamento o su una specifica forma. L’altezza dei livelli e la spettacolare terrazza panoramica da cui si può scorgere Casalecchio, Bologna e i colli della basilica di San Luca, catalizzano la bellezza degli artworks che appaiono monumentali e si stagliano su uno sfondo ameno. Così, la periferia si prende la propria chance di rivalsa nei confronti dei salotti e delle terrazze borghesi del centro città, troppo spesso indici di esclusività e di privilegio. La spinta dal basso proveniente da ragazzi animati da un solo desiderio -quello di potersi esprimere tramite il proprio modo di fare arte- ha portato già di per sé un’opportunità di riqualificazione, ma sembra che questa continui ad essere intaccata dalle minacce di abbattimento e dalle forze dell’ordine. Queste, infatti, spesso si recano sul posto per tirare fuori gli ospiti spontanei della struttura e cacciarli dalla zona, in nome di una sicurezza che non possono garantire. Ma quel Mostro rappresenta per molti una delle poche occasioni di riscatto, di libertà di espressione, un luogo sollevato dalla realtà quotidiana cittadina, realtà in cui i graffitari (come altri artisti) hanno sempre meno spazio per le loro creazioni.
Questo è dovuto principalmente ad una forma di discriminazione subita dal writing, che ancora oggi è considerata un’attività vandalica ed è tenuta al di fuori della cerchia dell’arte. A mio parere, l’unica forma di vandalismo è quella praticata dalle istituzioni, che prima favoriscono la costruzione di strutture simili tramite l’abusivismo e lo spreco di risorse, per poi pretendere di lasciarle giacere nel nulla provocando un danno irreparabile nei confronti della natura. Non può essere considerata vandalismo, invece, una forma di espressione che nasce dall’emarginazione di un gruppo di persone che, privato di qualsiasi altro spazio per manifestare la propria voce, decide di utilizzare quello che non viene utilizzato e quindi di riconvertire la distruzione in creazione. Una forma di riciclaggio autoprodotta e autofinanziata che viene estromessa dalle connotazioni artistiche ufficiali proprio per il suo essere così spontanea e contrastante rispetto al pensiero comune. Ma cosa c’è di più artistico di una forma di comunicazione che si sublima attraverso la bellezza estetica? Non è questa l’arte? Oppure si parla di arte solo quando si entra in una galleria, in un museo, in un qualsiasi raccoglitore di manufatti comunemente riconosciuti come opera solo per il fatto di essere posizionati in un determinato contesto? Purtroppo anche questo mondo si è piegato sotto i colpi dell’oggettificazione dovuta al commercio, al fatto di considerare l’arte come un prodotto che ha valore solo in virtù del proprio corrispettivo economico. Un motivo in più per considerare il writing un’attività rivoluzionaria oggi come sessant’anni fa, perché prende forma dalle macerie di un mondo corrotto e rimette insieme i cocci per creare qualcosa di bello.
«Arte è tutto ciò che gli uomini chiamano arte» scrive il filosofo italiano Dino Formaggio. Mai come nel ventunesimo secolo si può essere d’accordo con questa affermazione. Il secolo scorso ha portato una ventata di cambiamento in cui l’opera d’arte ha perso la sua aura (per dirla con Benjamin) e la sua unicità, subordinata per lo più alla maestria tecnica, per acquistare una dimensione universale che valorizza soprattutto il contenuto. Questo non vuol dire che ogni oggetto può essere casualmente e arbitrariamente investito dello statuto di opera d’arte, ma che ogni persona ha la possibilità di esprimersi e creare qualcosa che abbia alla base un messaggio: la nuova opera d’arte, prima di tutto, è un atto comunicativo. Credo che sia questo il denominatore comune dell’opera d’arte, ovvero la necessità di dire qualcosa e di veicolare un contenuto. Non più frutto di una bellezza formale autoreferenziale e di una erudita sapienza manuale, l’arte si separa dalla sua concezione mitica e religiosa per scendere nel popolo e mettersi alla portata di chiunque abbia la voglia di comunicare un messaggio. Non sembra proprio il caso dei graffiti? Sì, ma come ogni fenomeno, anche questo va incontro alle sue degenerazioni e così oggigiorno assistiamo ad una forma di commercializzazione di quello che è comunemente considerato anticommerciale. Il mercato sembra risucchiare al suo interno qualsiasi parte della vita sociale, decretando la vittoria del prodotto commerciale sull’ispirazione artistica. Conseguenza di ciò è la polarizzazione del dibattito tra street-art e writing, in cui la prima è la forma più riconosciuta e consacrata presso i circoli artistici ufficiali, mentre la seconda mantiene la propria indole emarginata ed illegale. I writers accusano gli street-artist di essersi venduti alle logiche commerciali, tanto da rivendicare fieramente la propria autonomia; ma a mio parere si tratta della stessa identica forma d’arte, che va incontro necessariamente ad una degenerazione nel momento in cui entra in contatto con la società di massa, la quale pretende di risucchiare tutto nei suoi canoni estetici e comunicativi. La nascita della sorella borghese del writing è un atto di appropriazione indebita che la società pratica nei confronti di una forma artistica al fine di nobilitarne l’essenza, ritenuta troppo scomoda e anticonvenzionale. Citiamo Banksy, l’esempio più lampante di questa polarizzazione. Nasce sicuramente come writer, considerando che gran parte degli interventi artistici che lo hanno consacrato sono illegali, tant’è che tiene la sua identità segreta perché vittima di numerose denunce. Si evolve, tuttavia, come street-artist, conseguenza naturale della sua diffusione nel mondo e della sua divenuta “pop”. Esattamente l’opposto, dunque, l’underground che si fonde con il mainstream: i confini di questi due mondi appaiono sempre più sfocati. Per questo intendo dire che nella realtà artistica contemporanea non esiste una differenza così netta tra street-art e writng, ma sono entrambe facce della stessa medaglia. Come in ogni forma artistica esistono solamente due tipi di opere: quelle fatte bene e quelle fatte male. E quelle fatte male (spesso) non sono tali solamente per mancanze conoscitive o tecniche, ma soprattutto perché mancano di un contenuto effettivo. Quest’ultimo è così importante ai fini di un riconoscimento artistico perché è quello che realmente muove la creazione artistica, l’esigenza intrinseca di un individuo che ha bisogno di comunicare quel messaggio per il proprio sostentamento, perché senza quell’espressione non potrebbe vivere. La creazione artistica non viene mossa dalla possibilità di fare business, ma dalla necessità viscerale di veicolare un contenuto.
Oserei dire che l’entrata dell’underground all’interno del mainstream offre nuove possibilità al writing, ovvero quella di poter essere riconosciuto finalmente come arte. Non che servano certificazioni ufficiali certo, ma sarebbe importante smuovere le coscienze verso l’evidenza che l’arte pubblica è uno strumento di espressione, quindi di costruzione, e non di vandalismo, quindi di distruzione. Resta comunque necessaria la rivendicazione di una differenza identitaria, che questa forma d’arte e di espressione mantiene nei confronti delle istituzioni e della commercializzazione. L’antidoto contro la stigmatizzazione del writing sta, almeno in parte, nel recupero degli insegnamenti che arrivano dal secolo scorso, in cui il valore della performance e dell’esperienza viene esaltato a discapito dell’oggettificazione dell’opera d’arte: l’opera non è più costituita dall’oggetto in sé, bensì dall’atto e dalla circostanza da cui scaturisce, che esso sia una protesta, un happening, una celebrazione, ma anche un’occupazione, una riqualificazione spontanea, un’appropriazione di spazi abbandonati. La possibilità che questo antidoto attecchisca, poi, sta nella presa di coscienza comune di un concetto semplice: l’arte del writing mette le toppe laddove le istituzioni hanno creato dei buchi (frase che vale sia in senso concreto che metaforico). La critica che emerge dai graffiti non è un atto di violenza o di vandalismo, ma di libertà di espressione praticata da artisti a cui è sempre stata negata.
«Questi artisti si sono scontrati inesorabilmente e senza successo con quei tipi di perversione sociale che descrivono così abilmente nelle loro opere, tanto che il loro sentimento di distruzione è stato facilmente emarginato e trasformato così in autodistruzione, distruzione del sé» scrivevo all’inizio del pezzo, riferendomi agli artisti decadenti. Faccio notare come le stesse righe siano ripetibili ugualmente per i writer: corsi e ricorsi storici, dunque. Tuttavia, a duecento anni di distanza, pare che le persone non abbiano imparato nulla dalla storia e, anzi, siano ancora più propense a conformarsi a degli standard sociali che escludono la possibilità di voci contrastanti. E una delle prove di tutto ciò sta proprio nella storia del Mostro di Casalecchio, così come in tante altre strutture di questo tipo disseminate sul territorio nazionale e mondiale. Il pensiero positivo riguardo l’abbattimento di questa struttura risiede nella noncuranza dei più (si curano certo del fatto di abbattere, ma non di quello che effettivamente abbattono), principalmente persone che non c’entrano nulla con ciò che accade quotidianamente al suo interno, ma che si arrogano il diritto di decidere a riguardo. Per non parlare delle aziende che in questi anni si sono rimbalzate le relative responsabilità, minacciando continuamente l’abbattimento senza avere le risorse economiche necessarie neanche per quello.
Sarò ripetitivo, ma perché abbattere quando si può costruire? Questo posto è una valvola di sfogo per artisti e curiosi, che negli anni hanno continuato a frequentarlo e, quindi, a rivalutarlo. L’ultima volta che sono stato al Mostro c’erano persino dei cineasti che giravano un cortometraggio, oltre ai soliti writers che riempivano di colore e di scritte i muri della terrazza. Perché rinunciare a tutto ciò? Nel 2015 il comune di Milano ha ben pensato di rivalutare un parcheggio abbandonato nel quartiere della Barona che era stato trasformato in un museo a cielo aperto dai writers locali, organizzando un happening di arte pubblica, street art, graffiti e poesia di strada per salvare i muri dal degrado del tempo e regalare alla cittadinanza un’opera che racconti la storia del luogo. Il Mostro che diventa Mostra, l’ecomostro che diventa Ecomostra, questo il nome scelto per l’evento. Basta una lettera per cambiare la percezione delle cose e la distruzione diventa costruzione. L’arte offre numerose possibilità di rigenerazione urbana e di questo si occupa il writing da sempre, tuttavia l’Italia è ancorata ad una dimensione di scetticismo e di pigrizia intellettuale che fanno prevalere la volontà di abbattere piuttosto che quella di riciclare, ricostruire, ricreare. Così come avviene in un museo istituzionale, in una galleria indipendente, in una mostra autogestita -o quel che sia- il Mostro di Casalecchio continua ad ospitare turisti, curiosi, artisti di ogni genere, attirati dalla bellezza e dalle possibilità creative. Invece di sprecare ulteriori risorse per completare la distruzione voluta e causata dalla negligenza direzionale, questo luogo andrebbe rivalutato così com’è, nella sua parziale integrità, ma totale bellezza. Attraverso una messa in sicurezza dello spazio e una legalizzazione di quello che avviene al suo interno, il Mostro potrebbe rappresentare una risorsa per l’intera comunità sia locale che nazionale. Dico di più, questo progetto andrebbe gestito dal basso, togliendolo dalle mani delle aziende che per anni lo hanno dissipato e abbandonato, per essere riassegnato a quegli stessi ragazzi che ne fanno uso e che lo valorizzano in tutta la sua unicità. Immaginate l’aggregazione artistica e sociale che si potrebbe sviluppare attorno ad un posto del genere! Non sarebbe né un museo né una galleria, anzi potrebbe rappresentare una forma di fruizione, esposizione e pratica artistica completamente nuova ed inedita, che rappresenterebbe una possibilità rivoluzionaria per il mondo dell’arte, per quello del writing e per la società intera. Ma si parla ancora al condizionale. Ed è questo il punto.
L’arte può rappresentare davvero il riscatto sociale di un’intera generazione nei confronti della degenerazione imposta dai padri. Essa fornisce la possibilità di una nuova nascita (o rinascita) nei confronti del materialismo e dell’odio precostituito, che invece costituiscono la morte dell’anima. L’arte indica la strada per costruire sulle macerie provenienti dal passato, ma troppo spesso si scontra con una forma di società lobotomizzata, figlia di valori falsi e costruita su illusioni deboli, che condanna il pensiero alternativo a causa dell’ignoranza generata dai media, che a sua volta alimenta la paura nei confronti della diversità; da qui la preferenza per l’abbattimento, “tanto non mi riguarda”. Ma se i modelli precostituiti hanno fallito perché hanno gettato una distruzione sia sociale che naturale su questo pianeta, la pratica artistica si propone di invertire la rotta e di costruire un’alternativa anti-sistemica e circolare che possa riconsiderare la percezione che abbiamo delle cose, delle persone, della natura, del mondo nel quale viviamo.
Dai taccuini di Jean-Michel Basquiat
I
Quando i poeti cancellano
Gli ultimi silenzi della notte
Le mani di un ragazzo
Scarabocchiano versi sui muri delle città
Le parole diventano stelle del desiderio
Coriandoli di morte variopinta
Intermittenze di luce
Che inghiottono la notte con un respiro.
Altrove il popolo dei vinti
Cammina silenzioso verso i metrò
E uomini soli coltivano nidi d’angoscia
Con le facce schiacciate sui vetri
Mentre negli occhi scorrono i divieti di una vita
“Vietato attraversare i binari”
“Vietato parlare al conducente”
“Vietato sognare altri mondi…altri amori”.
VIETATO VIETARE!
Scrivono invece
Le rondini metropolitane
E disegnano sui muri
I loro sogni colorati.
II
Lasciano impronte di libertà
Sui vagoni dei treni
Nelle stazioni di periferia
Nei centri sociali
Sognando solo di avere un futuro
Una speranza, un segno che li tenga vivi
In un mondo di morti viventi
Di anime addomesticate al male di vivere.
E tu Michel
Eri un frammento di stella contaminata
Da vite clandestine e sole
E cercavi tra i rifiuti e gli scarti
Il delirio del mondo
Che ignora il proprio delirio.
Cercavi ogni indizio di vita estrema
Un’estasi, una musica vera
In cui perdersi per ritrovarsi.
III
Vorrei perdermi nel tuo respiro
Tra le pagine magiche
Dei tuoi taccuini
Tra le tue cancellazioni
E le tue illuminazioni.
Ma ci restano solo le tue contaminazioni e collaborazioni
Con Andy Warhol e con Francesco Clemente
I tuoi ritratti impazziti
Come Artaud, come Rimbaud.
Piccolo corsaro nero
Ricasso in black
Scoiattolo di Downtown
Ti scambiavano per un Armani di periferia
E non vedevano che eri
Un principe degli Atelier
Il gran Visir della strada.
Le ossequiose maestrie del Rococò
I mercanti squali
Squallidi replicanti del neo-pop
I pompiers del Dejà Vu
Le crocerossine di Canova
Li hai annientati tutti
Cercando il nuovo, il vero, l’altrove.
Gettavi il tuo cuore oltre il limite
Ma il tuo corpo
Era una grata di sogni
Contro la mattanza quotidiana
Della creatività
Testo e fotografie di Gaetano Sorbo (@tanuzzo_st)