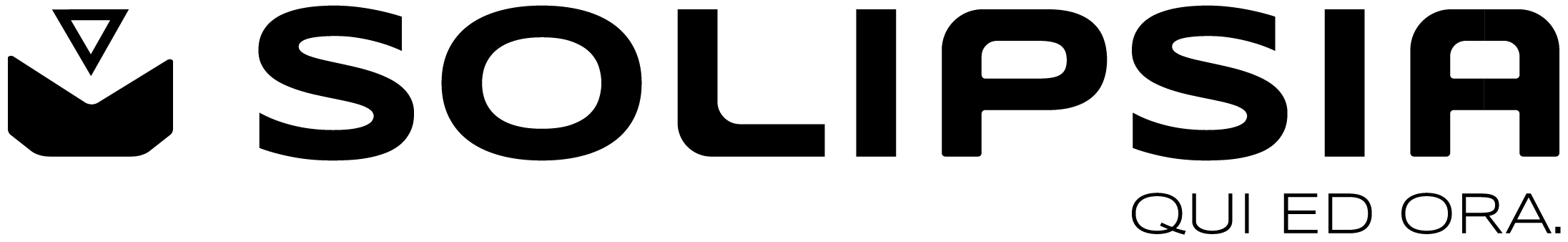Sono passate ormai settimane dall’inizio delle rivolte che stanno mettendo a ferro e fuoco gli States, scatenate dall’ennesimo omicidio di stampo razziale della polizia americana. Il gesto di Derek Chauvin, con cui l’ormai ex agente della polizia di Minneapolis ha ucciso l’afroamericano George Floyd, ha fatto il giro del mondo in poche ore. Tutti sono stati resi testimoni a mezzo video di questo evento dalla chiarezza schiacciante: un uomo abusa della sua divisa per uccidere un afroamericano che, mentre si ritrova premuto al suolo, chiede disperatamente pietà.
«Fatelo entrare in macchina!», grida la gente che si trova sul posto.
«Sta morendo!» fa notare agli agenti.
George risponde: «Non posso muovermi! Non respiro!».
Successivamente, a giudicare dalle grida, l’agente intensifica la pressione con il ginocchio sul collo dell’afroamericano che, lentamente, si lascia andare alla morte. Una scena terribile che sarebbe meglio se non fosse mai accaduta e, di conseguenza, mai stata ripresa. Tuttavia, questo episodio non sarebbe mai saltato con questa prepotenza agli onori della cronaca se quel video non avesse avuto una tale diffusione. La potenza delle immagini ha reso miliardi di persone spettatrici e testimoni di un atto efferato, che le ha messe davanti ad un fatto inequivocabile: gli abusi di potere e la violenza inaudita della polizia americana contro un uomo di colore. Ovviamente, non è la prima volta che accade un atto del genere, basti pensare all’omicidio di Eric Garner nel luglio del 2014, ucciso alla stessa maniera, anch’egli esalando come ultimo respiro quel «I can’t breathe». Oggi, questa frase è diventata lo slogan delle proteste che stanno infiammando il Paese. Stavolta non hanno vinto silenzio e omertà perché il popolo ha deciso di ribellarsi, anche grazie a quel drammatico long take di 8 minuti che ha messo tutti davanti all’evidenza dei fatti. Ma quante violenze e quanti casi simili rimangono isolati nel baratro senza una voce? Stavolta la contingenza ha “fortunatamente” portato qualcuno a filmare quell’atto efferato, ma bisogna domandarsi: quanti atti del genere accadono senza che ce ne accorgiamo?
Molti hanno provato a circoscrivere la tematica alla sola realtà nazionale degli Stati Uniti, tuttavia un approccio del genere è indubbiamente riduttivo, in quanto non tiene conto di una serie di fattori: in primis, gli US influenzano notoriamente una grande parte delle dinamiche di potere mondiali, indirettamente o meno, attraverso accordi commerciali e politici o mediante l’invio di militari e armi in zone d’interesse. In secondo luogo, l’influenza statunitense riguarda dinamiche culturali e artistiche: pensiamo a gran parte della musica di cui fruiamo, i film, le serie tv e soprattutto le tendenze ed innovazioni, che spesso partono dagli US per poi svilupparsi sul mercato mondiale.
Allo stesso modo, molte delle tematiche d’oltreoceano si sono spesso diffuse worldwide, entrando direttamente nelle case delle persone. Sarebbe assurdo, oltre che estremamente ingenuo, pensare di collocare la vicenda di George Floyd in un quadro esclusivamente “americaneggiante”, dato che i problemi del razzismo e degli abusi di potere non hanno nessuna bandiera nazionale né alcuna appartenenza geografica specifica: nel 2020, possiamo dire che questi problemi siano delle vere e proprie pandemie globali, anche se spesso vengono ignorati.


Nel caso di George, però, la potenza delle immagini e la loro rapida diffusione ha quantomeno consentito una polarizzazione tematica. Per dirla in parole semplici, tutto il mondo parla della stessa cosa perché influenzato da migliaia di contenuti online che, seppure diversi l’uno dall’altro, tendono ad influenzarne il pensiero: se consideriamo il drammatico video dell’omicidio di Floyd, vediamo come esso abbia giustamente rappresentato una scossa nella coscienza individuale e collettiva.
Preso atto di questo, credo sorga spontanea una domanda: «C’è davvero bisogno di immagini per smuovere le coscienze su un argomento così noto?». Evidentemente si. Appare quindi evidente un altro grande problema, ovvero il fatto che alcune situazioni non godano della stessa diffusione di contenuti che le testimoniano; o che questi contenuti non siano tanto d’impatto quanto vedere una persona che muore davanti ai propri occhi. O che la violenza, la discriminazione e la morte debbano essere spettacolarizzate per ricevere considerazione. Di conseguenza, è facile intuire che tanti altri casi di razzismo e abusi di potere simili a quello di George Floyd rimangano quotidianamente nell’ombra anche se all’ordine del giorno in tutto il mondo, indipendentemente dal tipo di governo dei singoli stati (basti pensare che gli States sono considerati un Paese democratico). Queste vicende, seppur numerosissime, costituiscono una nicchia di informazione a cui non viene concesso il giusto interesse, semplicemente perché spesso lontane dal grande clamore mediatico. La triste vicenda di George dovrebbe aprire gli occhi su molte tematiche frequentemente dimenticate o ignorate (seppur molto vicine a tutti noi), tuttavia il pensiero comune tende a scindere quello che è accaduto a Minneapolis da altre situazioni, che in realtà sono omologhe. Il razzismo è infatti un approccio mentale molto diffuso sia in America che nel resto del mondo, così come gli abusi di potere sono una prerogativa che sta alla base del solo fatto di avere quel potere, come dirò di seguito. Ecco perché l’omicidio di George Floyd riguarda tutti, ma proprio tutti, nessuno escluso.


Spostiamo l’attenzione in Italia per comprendere l’universalità di questi problemi più da vicino. La tipica indignazione all’italiana si è presa la scena anche stavolta, mostrando l’ipocrisia schiacciante di chi fino al giorno prima era dalla parte dell’oppressore. Come se il razzismo che ha portato all’uccisione di George fosse diverso da quello che porta i migranti a morire in mare o nei campi. Non c’è da sorprendersi: l’italiano medio è lo stesso che diceva «Andateli ad aiutare a casa loro» e poi giustificava il rapimento di Silvia Romano con uscite tipo «Chi gliel’ha detto di andare in quei luoghi?».
O ancora, come se gli abusi di potere perpetrati ai danni delle minoranze (dove per minoranza si intende qualsiasi categoria sociale vittima di discriminazione) fossero diversi da altri omicidi e sfruttamenti avvenuti in terre nostrane. Penso al caso di Stefano Cucchi, che ha avuto la “fortuna” di passare agli onori della cronaca e, quindi, ricevere la luce necessaria ad indagare sugli atti efferati che hanno deciso la sua morte e all’incarcerazione dei due carabinieri responsabili, avvenuta grazie alla tenacia della famiglia e di tutte le realtà che per dieci anni si sono battute per far emergere la verità. L’iter giudiziario è stato infatti lungo e, fino a poco prima delle ultime sentenze, diversi rappresentanti delle istituzioni consideravano Stefano semplicemente un “drogato che aveva pagato per la sua vita dissoluta”. Anche qui, a processo concluso gli italiani -e le istituzioni tutte- hanno esultato perché “giustizia è stata fatta”, ma come si può parlare di giustizia dinanzi all’evidenza che, oltre a Stefano, molti altri sono morti nel silenzio generale e, insieme a loro, sono stati cancellati anche gli abusi perpetrati dalle forze dell’ordine? Senza contare le decine di casi degli ultimi anni (molti dei quali ancora in attesa di verità) mi viene in mente la storia di Francesco Lorusso a Bologna, risalente al 1977: il ragazzo venne ucciso durante una manifestazione studentesca da un carabiniere e -come nel caso di George, ma in dimensioni ridotte- l’accaduto portò ad una serie di scontri che si verificarono nei giorni successivi. Tuttavia, questa vicenda godette solo di un’attenzione locale e il carabiniere responsabile fu scarcerato dopo circa un mese perché, pur avendo commesso il fatto, aveva agito in maniera “legittima” rispetto alla Legge Reale: un antico editto che prevedeva che le forze dell’ordine potessero sparare contro i manifestanti, anche solo per mantenere l’ordine pubblico.
D’altro canto, gli abusi in divisa perpetrati quotidianamente provengono da sempre sia dalle forze dell’ordine che da quelle delle istituzioni (per cui si intende una divisa metaforica). Anzi, gli abusi di potere, nella loro accezione più generale, sono possibili perchè legittimati dalle gerarchie e dalle decisioni istituzionali, mentre innumerevoli vite se ne vanno nel silenzio generale. Fra queste ci sono le vittime del mare, di cui viene difficile persino tracciare numeri reali, la cui sorte è dipesa e dipende proprio dagli abusi del potere.
L’Italia vive una situazione in cui le istituzioni stanno programmaticamente abbandonando le dinamiche umanitarie. La legge Fini-Bossi, risalente a 18 anni fa, costituisce le basi della volontà implicita di rimpatriare i migranti che arrivano in Italia, rendendoli di fatto fuori legge ancor prima del loro arrivo. Infatti, il migrante è considerato clandestino fin quando non riesce a regolarizzare la propria situazione, tra i tempi infiniti della burocrazia italiana e le molteplici difficoltà lavorative. Inoltre, le forze dell’ordine possono respingere -anche con la forza- i migranti che si trovano in acque extraterritoriali al fine di evitare lo sbarco, lasciando addirittura le eventuali cure mediche in balia del mare. Paradossalmente, chi aiuta i migranti al fine di salvaguardarne l’incolumità (come le Ong) è accusato di favoreggiamento e rischia fino a 3 anni di carcere, mentre chi realmente dovrebbe scontare una pena per lesione dei diritti umani fondamentali fa la voce grossa e gode di poltrone governative.


Le ciliegine su questa torta di merda sono stati i decreti sicurezza dello scorso anno, grazie ai quali il ministro dell’interno può decidere autonomamente riguardo il respingimento di navi in acque territoriali e viene abolita la protezione per motivi umanitari. Questo vuol dire che lo Stato non solo si rende complice delle vittime del mare, ma è pronto a speronare qualsiasi nave di soccorso che si opponga a questa strage. Chi fugge da guerre, disastri naturali, persecuzioni e sfruttamento, potrebbe non riuscire a fuggire o avere diritto ad un regolare permesso di soggiorno, perchè le istituzioni italiane ed europee abusano del loro potere, calpestando ogni diritto umano fondamentale. Come ha ricordato di recente Aboubakar Soumahoro, esistono delle persone esattamente come noi, che tuttavia sono invisibili.
Il rischio di arrivare in Italia da clandestino, infatti, favorisce il caporalato, un fenomeno vecchio come il mondo che assoggetta il migrante ad un “caporale”, il quale lo impiega come bracciante/operaio senza rispettare alcun diritto del lavoratore, anzi sfruttando la sua disperazione per risparmiare sulla manodopera. È di qualche giorno fa la notizia della morte di un bracciante -soltanto l’ultimo di una lunga serie- in una baraccopoli vicino Foggia, così come lo è quella della morte di oltre cinquanta naufraghi che cercavano di raggiungere l’Italia la scorsa settimana: casi come questi, pur essendo all’ordine del giorno, non risaltano nel panorama mediatico mainstream o, se lo fanno, vengono troppo spesso strumentalizzati dagli sciacalli di turno, disposti a barattare voti con vite umane. Vite -e morti- che vengono intanto dimenticate, come se non fossero un problema grave di cui occuparsi, come se non si trattasse di uomini e donne che perdono la vita a causa dei governi, delle scelte politiche, della criminalità, della guerra, della totale noncuranza dei diritti umani fondamentali.
La struttura istituzionale conosce bene queste problematiche, ma, attraverso la retorica del benaltrismo, persiste nell’accantonare determinate questioni in favore di altre più redditizie, considerate “più importanti”. Di recente, la ministra per le politiche agricole Bellanova ha tentato di mettere una toppa al problema, attraverso una maxi-sanatoria che avrebbe dovuto riguardare le vittime del caporalato. Tuttavia, ha poco dopo dichiarato che «le condizioni date» (qualunque cosa voglia dire) non hanno consentito che questa norma venisse adottata integralmente. Basti pensare che, secondo le stime della Caritas, i lavoratori “invisibili” sono più di 500’000, mentre la sanatoria ne comprenderebbe solamente 65’000. Sembra così un tentativo di mettere delle pezze dove l’acqua fuoriesce in maniera impetuosa.
D’altronde ogni stato, nonostante le diversità storiche e culturali, è assoggettato alla stessa retorica, con effetti spesso catastrofici. Considerata l’ipocrisia delle istituzioni, non sarà di certo una legge a cambiare le cose. Il sistema è marcio fin dentro le fondamenta, per cui la soluzione è da ricercare al di fuori di esso. A riprova di ciò, la morte di George Floyd in America ha provocato una gigantesca, tumultuosa reazione popolare che non solo ha riaperto un storico dibattito scomodo a molti, ma ha addirittura innestato nella popolazione il bisogno di reinventare, proporre e realizzare esempi alternativi di convivenza urbana, scevri dalle logiche dominanti dei sistemi conosciuti. Ne è un esempio il recente smantellamento del corpo di polizia di Minneapolis, o la creazione di una vera e propria Zona Autonoma nel centro di Seattle, a Capitol Hill, denominata CHAZ: un intero quartiere, occupato dopo giorni di scontri ed auto-organizzato dalla popolazione locale, in cui polizia, razzisti e suprematisti non sono i benvenuti.


Se è vero che la soluzione parte dal basso, è però anche vero che il problema degli abusi di potere, commessi dalla polizia e dalle istituzioni -statunitensi e non- nei confronti delle minoranze, trova le sue radici in un substrato mentale duro a morire. Il razzismo dovrebbe essere un concetto appartenente al passato, ma purtroppo si rivela più attuale che mai. Persino secondo le dichiarazioni dell’Alto Commissario Onu, le manifestazioni seguite alla morte di George Floyd hanno fatto luce sulle «discriminazioni razziali endemiche» degli Stati Uniti. Il malessere della minoranza afroamericana è stato infatti nascosto per anni come polvere sotto al tappeto, schiacciato dal benessere dei più e dalle derive del suprematismo bianco, un’ideologia ancora forte negli States. Tuttavia, quella polvere è riemersa, dimostrando quanto sia sporca la coscienza delle istituzioni: sempre secondo l’Onu, le proteste hanno evidenziato problematiche nascoste quanto ricorrenti quali «disuguaglianze nella sanità, nell’istruzione e nel lavoro, a causa della discriminazione razziale».
È noto come, per anni, la classe dirigente statunitense abbia giocato con la vita degli afroamericani, prima schiavizzandoli (fino ad un secolo e mezzo fa) e poi relegandoli nei famosi ghettos, di fatto promuovendo forme implicite di discriminazione sociale. La segregazione razziale negli USA è durata fino a sessant’anni fa, quando è stata dichiarata illegale dopo mezzo secolo di proteste. Tuttavia, nonostante le successive leggi di abolizione, è evidente come questa segregazione non sia mai finita, almeno dal punto di vista mentale. Il razzismo esiste ancora e, nonostante gli Stati Uniti si fregino di essere il Paese più potente del mondo, di certo non lo sono per quanto riguarda i diritti fondamentali dell’uomo. Lo ha sottolineato persino il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, che si è espresso riguardo agli accadimenti di Minneapolis. Dopo aver elencato alcuni nomi di afroamericani uccisi dalla polizia, ha affermato:
“Il vero problema in questo Paese è il continuo razzismo. Esso è cronico, endemico, istituzionale e parla dell’ipocrisia collettiva. Siamo molto bravi a dire alle persone come dovrebbero vivere le loro vite, come dovrebbero agire, ma noi facciamo ancora discriminazioni sulla base del colore della pelle. Questa è la semplice e dolorosa verità”.
Come spesso accade, il benessere economico occulta le disparità sociali, portando la popolazione all’assopimento e all’azzeramento dell’empatia: se io sto bene, sono portato a dedurre che anche ciò che mi circonda vada bene. Tuttavia, non è mai stato così: ancora oggi, un paese come gli USA, nato dalle ceneri del colonialismo bianco, fondato sulla presunta indipendenza dei popoli e con una storia di lotte sociali decennali, si ritrova nuovamente a scontrarsi con la piaga del razzismo. D’altronde, il termine “endemico”, usato sia dall’Onu che da Cuomo, sottolinea come il razzismo negli States abbia un legame viscerale con la loro storia e cultura. Ancora oggi, infatti, il censimento statunitense prevede una distinzione di “razza ed etnicità” tra le voci riportate.
Come una malattia, il razzismo non ha mai abbandonato la storia americana (e mondiale), anzi si è evoluto. Per quanto, rispetto al passato, la condizione di accettazione degli afroamericani all’interno della società sia sicuramente migliorata (specialmente tra le nuove generazioni), i quartieri poveri sono tutt’ora popolati principalmente da persone di colore, molte delle quali non possono permettersi neanche l’assistenza sanitaria perché disoccupate. Anche qui, come fatto notare precedentemente per l’Italia, il governo statunitense ha da tempo abbandonato le dinamiche umanitarie, pensando di limitarle con la repressione: l’inasprimento delle forze di polizia riguarda infatti principalmente i quartieri poveri, così come gli arresti che, sempre di più, colpiscono persone afroamericane residenti in zone circoscritte. Uno studio molto interessante a riguardo è quello condotto da Eric Cadora nel Justice Mapping Center , in seguito al quale sono sorti numerosi lavori, noti anche come Million Dollar Blocks, impegnati nell’obiettivo di testimoniare, attraverso l’aiuto della componente visiva, come la grande maggioranza degli arresti che avvengono negli US siano effettuati ai danni di persone di colore o residenti in specifici quartieri. Come precedentemente detto, il sussidio visivo è utile poiché d’impatto e, in questo caso, è stato usato dai ricercatori per fare luce sulla questione. Lo studio, attraverso i dati, ha dimostrato una tendenza evidente: le istituzioni americane hanno scelto di bypassare le cause per le quali avvengono determinati crimini, come la povertà, spendendo invece quantità massive di fondi per l’incarcerazione di massa e la violenza armata. Questo razzismo istituzionale, nel tempo normalizzato, porta ad un razzismo civile: alcune persone si sentono messe in pericolo dal “diverso” (diversità etnica o sociale che essa sia) e procedono così come gli è stato insegnato, ovvero discriminando, senza approfondire quella diversità ed indagarne le cause con spirito critico. Allo stesso modo, le devastazioni perpetrate dai manifestanti sono figlie della violenza che le istituzioni stesse hanno insegnato, come ha fatto notare l’attivista del movimento Black Lives Matter, Tamika Mallory, in un discorso alla stampa diventato virale.
In troppi condannano i riot, in pochi capiscono quanto questa rabbia sia necessaria. La storia ci insegna che le cose non sono mai cambiate da sole: al contrario, lo status quo ha interesse nel rimanere tale se non viene scosso in qualche maniera. Chiaro, ribellarsi non è abbastanza: bisogna costruire, educare, informare e diffondere la cultura. Come dicevamo prima, le proteste hanno infatti avuto un primo riscontro positivo: il consiglio comunale di Minneapolis ha votato in maggioranza, contro il parere del sindaco, per avviare un processo di smantellamento del dipartimento di polizia. Questo dovrebbe portare ad una redistribuzione delle risorse economiche verso alcuni servizi sociali di base (come l’assistenza abitativa e sanitaria) oltre ad istituire un sistema alternativo di sicurezza pubblica che preveda il disarmo delle forze dell’ordine, dato che la maggior parte delle persone uccise dalla polizia non portava con sé alcuna arma. Tuttavia, vista la strenua resistenza e persistenza delle proteste, i provvedimenti di Minneapolis potrebbero rientrare in un quadro riformista volto a placare gli animi, considerando che la polizia locale rappresenta solo una delle svariate forze armate nazionali e federali presenti su tutto il suolo americano. Ad ogni modo, si tratta di una dinamica rivoluzionaria e auspicabile: basti pensare a quanta violenza e repressione potrebbero essere risparmiate in virtù di conoscenza e sussidi. La causa della popolazione afroamericana, infatti, è emersa con ancora più veemenza in correlazione agli abusi di potere violenti perpetrati dalle autorità nei loro confronti. Il sito mappingpoliceviolence.org contiene una grande quantità di dati riguardanti i soggetti uccisi dalla polizia, organizzati secondo mappe e grafici interattivi che permettono di incrociare informazioni quali l’etnia e la zona dell’accaduto. Qui sotto vi lasciamo la mappa interattiva delle violenze dell’ultimo anno, che ben rende l’idea delle proporzioni della questione.
(Ogni segnaposto corrisponde ad un caso: è possibile leggerne i singoli dettagli cliccandoci sopra o ricercare casi e località specifiche dalla barra di ricerca.)
Secondo queste ricerche, un afroamericano ha tre volte di più la possibilità di morire per mano di un agente rispetto ad un bianco. Inoltre, il 99% degli omicidi causati dalla polizia dal 2013 al 2019 non risulta accompagnato da alcun tipo di accusa giudiziaria. Questo dimostra come il problema del razzismo trovi le sue radici all’interno delle dinamiche di potere che governano le istituzioni, comprese le questioni giuridiche. Non solo un problema americano, dunque, ma una piaga globale che, per altro, riguarda le maggiori istituzioni “democratiche” mondiali (oltre, chiaramente, alle dittature).
D’altronde, la detenzione di un potere comporta sempre (o quasi) un conseguente abuso dello stesso. L’asservimento alla legge non ha mai garantito un’effettiva giustizia sociale, ha tuttalpiù fornito alla classe dirigente un potere sempre maggiore. Al fine di conservare questo potere, i governatori hanno assegnato alla polizia sempre maggiori libertà pur di mantenere «Law and order», come, non a caso, ha tweettato Trump in risposta ai disordini a Minneapolis ed in tutto il Paese.
Tuttavia, non viene mai considerata la possibilità che la legge possa essere iniqua, sbagliata, corrotta, e che quindi coloro che si occupano di farla rispettare potrebbero agire sia contro il popolo che contro sé stessi. Il filosofo Henry David Thoreau, vissuto al tempo dello schiavismo, la pensava così nel suo saggio Disobbedienza Civile:
“La legge non ha mai reso gli uomini più giusti; e, a causa del loro rispetto per essa, anche quelli ben disposti diventano quotidianamente agenti d’ingiustizia. Un risultato comune e naturale di un indebito rispetto per la legge è vedere una colonna di soldati, colonnello, capitano, caporale, reclute, portatori eccetera, che marciano in ordine ammirevole per vallate e colline per andare in guerra, contro la loro volontà e invero contro il buon senso e le coscienze. Non hanno dubbi che sia una faccenda riprovevole, quella in cui sono coinvolti; sono tutti inclini alla pace. E dunque, essi cosa sono? Ancora uomini? Oppure piccole fortezze e arsenali mobili, al servizio di qualche cinico uomo al potere? La maggior parte degli uomini serve lo stato in questo modo, non in primo luogo come uomini ma come macchine, con i loro corpi. Sono l’esercito permanente nonché i riservisti, le guardie carcerarie, i poliziotti, i volontari dello sceriffo eccetera. Nella maggior parte dei casi non c’è alcun libero esercizio della facoltà di giudizio o del senso morale; essi si pongono invece sullo stesso livello del legno, della terra e delle pietre, e forse si potrebbero anche costruire degli uomini di legno che servano lo stesso scopo. Eppure sono comunemente considerati buoni cittadini. Altri – come la maggior parte dei legislatori, dei politici, degli avvocati, dei ministri del culto e titolari di cariche – servono lo stato principalmente con la testa; e, dato che raramente fanno distinzioni morali, è tanto probabile che servano Dio quanto che servano il diavolo, senza farlo apposta. Un uomo saggio sarà utile solo in quanto uomo; non si adatterà ad essere “calce” e a tappare “un buco per tenere fuori il vento”, ma lascerà quel compito alla propria polvere.”
I membri delle forze dell’ordine non decidono da loro cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, ma agiscono secondo la volontà di terzi, che raramente pensano a cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Se questo terzo è un dittatore sanguinario, come spesso accade tutt’oggi in molte zone del pianeta, le forze dell’ordine si ritrovano nella posizione di uccidere o arrestare gli oppositori politici, perseguitare le minoranze etniche e sociali e commettere tutta una serie di efferatezze che apprendiamo dalla storia. D’altronde, in Italia è già accaduto, meno di un secolo fa.
Questo discorso, dunque, va ben oltre il fatto che, come sostengono alcuni, “ci sono poliziotti cattivi ma anche poliziotti buoni”. Esso riguarda piuttosto la concezione stessa dell’essere poliziotto e l’asservimento al potere che esso comporta: le forze dell’ordine non potranno mai essere parte della soluzione, in quanto essi sono gli stessi responsabili del mantenimento del problema: “semper fidelis”. Ecco perché non sarà una legge a cambiare le cose, ma un radicale mutamento della mentalità comune, nella consapevolezza che l’autodeterminazione degli individui sia un passaggio fondamentale per costruire un futuro basato sulla libertà piuttosto che sull’oppressione. Sempre Thoreau scriveva:
“Io so bene questo: che se mille, se cento, se dieci uomini che potrei nominare, anzi, se un solo uomo onesto, smettendo di tenere degli schiavi, dovesse nei fatti ritirarsi da questa compartecipazione, e per questo essere chiuso nella prigione di contea, ciò sarebbe l’abolizione della schiavitù in America. Perché non importa quanto piccolo possa sembrare l’inizio: ciò che è ben fatto una volta è fatto per sempre.”


Da questo dovrebbe ripartire l’umanità. Dalla consapevolezza che un solo gesto può rivoluzionare il mondo intero, generando un flusso invisibile che può sovvertire il pensiero e le abitudini precostituite. In questo senso, la disobbedienza è fondamentale per ottenere un futuro diverso, in cui le minoranze non siano più considerate alla mercé dei poteri forti -imposti con la violenza- e la libertà dell’individuo, che finisce laddove inizia la libertà del prossimo, sia riconosciuta come il presupposto alla creazione di una società migliore. Ancora Thoreau fa notare come:
“Non è così importante che molti siano buoni come voi, quanto che ci sia da qualche parte della bontà assoluta; perché un po’ di quella farà lievitare tutta la pasta.”
“Disobbedienza Civile” – Henry David Thoreau, 1849
Tutto ciò viene spesso celato o ignorato nei sistemi dominanti, che prediligono uomini inconsapevoli piuttosto che esseri pensanti: macchine al posto dei cervelli, ordine costituito anziché cambiamento. Non importa quanto il sistema sia marcio, ma importa che esso venga preservato.
La morte di George Floyd -con la sua portata mediatica- e le conseguenti rivolte in corso negli Stati Uniti hanno un respiro globale. Non solo evidenziano quanto sia sbagliata la società nella quale viviamo, parlano di come provare a cambiarla: il definanziamento della polizia di Minneapolis è solo il primo passo verso un tentato mutamento di mentalità che passi dalla coercizione all’informazione, dallo sfruttamento all’integrazione, dalla violenza all’ascolto. Una mentalità rivoluzionaria a livello globale, che influenzerebbe la maggior parte delle dinamiche sociali. Dalla pubblica sicurezza alle pratiche di mutuo soccorso e prevenzione della microcriminalità indotta, dal dibattito sulle droghe e relativa criminalizzazione alla discussione sul senso della detenzione carceraria ed alla ricerca di nuove pratiche rieducative, dalle discriminazioni e le mancanze di diritti all’affermazione di un’educazione individuale e collettiva scevra da pregiudizi razziali, sessuali o di alcun genere, sono innumerevoli le tematiche da affrontare in maniera del tutto diversa rispetto ad oggi. Spesso, esse sono adombrate dal dibattito pubblico, che ovviamente predilige necessità economiche, elettorali o burocratiche. Per questo motivo, quel maledetto video ha scatenato una reazione rabbiosa, che si pone di sovvertire il razzismo sistematico delle istituzioni e ha fatto luce su questioni da troppo tempo abbandonate, perché sistematicamente ignorate.


La consapevolezza che ci siano tante situazioni che rimangono nell’indifferenza generale ha creato un’eco potentissima, che si è diffusa nel resto del mondo come un effetto farfalla, un fenomeno fisico di particolare interesse metaforico: l’idea è che, inserendo delle piccole variazioni nelle condizioni iniziali di un sistema, si producano grandi variazioni nel suo comportamento. I fatti statunitensi dimostrano che «la rabbia è un dono» al quale, insieme alla cultura, non dovremmo mai rinunciare né osteggiare in favore di un moralismo sterile. Sicuramente George Floyd era inconsapevole che quel pomeriggio, quando è uscito di casa, avrebbe aiutato, seppur con la morte, milioni di persone ad esternare con tale potenza gli abusi e i soprusi che ogni giorno subiscono e condannano. Nessuna vita sarà sprecata fin quando i posteri sapranno renderle giustizia.


T. Supertramp