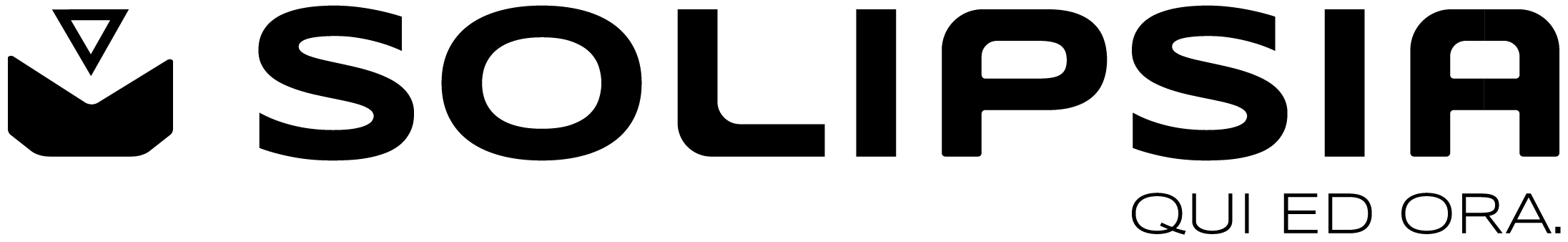Pochi giorni fa, in occasione del primo anniversario del movimento, le piazze delle maggiori città francesi sono state di nuovo invase dai Gilet Gialli. Ad un anno di distanza, qualche riflessione sul fenomeno che sta paralizzando la Francia.


Un Gilet catarifragente, di quelli che abbiamo tutti, magari sepolto da qualche parte in auto. Parafrasando la massima degli Indiani Pellerossa, con un po’ di ironia, verrebbe quasi da dire “Abbiamo disseppellito i Gilet di guerra!”.
In fondo, cos’è questo Gilet se non un simbolo? Di sicuro non molto rappresentativo o pregno di significati impliciti, ma geniale proprio per questa sua immediata semplicità. Riflettiamo un attimo: quale miglior simbolo se non un oggetto di uso comune, posseduto praticamente da tutti?
L’ennesima accise sul prezzo della benzina ed un rincaro sul pedaggio autostradale: è a partire da questi pretesti che è scoppiata la protesta. Le comunicazioni e gli aggiornamenti, sin dall’inizio del fenomeno, sono stati diramati tramite gruppi Facebook e catene WhatsApp. È importante soffermarsi sui motivi della protesta: è proprio su questo punto che si scontrano, tutt’ora, differenti vedute. L’enorme portata mediatica del fenomeno ha infatti accentuato, in molti casi, il dibattito sulle questioni sociali in ballo, rivendicate rispettivamente dalle opposte fazioni. Spesso, discutendo con amic* di varie e differenti latitudini e visioni, ho ravvisato in loro perplessità e problematicità sui contenuti che hanno dato il via alla lotta dei Gilets Jaunes, sommariamente sintetizzabili così: “Macròn ha fatto bene! Nell’epoca dell’Antropocene limitare e ridurre le emissioni è un fatto positivo, chi si oppone ha una visione ristretta e limitata.”
Ora, che il mondo sia stato sconvolto dalla nostra permanenza su di esso è indubbio, come lo sono anche le emissioni prodotte dai tubi di scappamento di milioni d’automobili. D’altronde, ragionando così limitatamente in questo frangente, si perdono di vista due aspetti fondamentali della questione, di cui uno in particolare, fondamentalmente “di classe”: è un fatto che più del 70% delle emissioni di CO2 a livello globale sia prodotto da 100 grandi aziende inquinanti fatturanti miliardi, distribuite per l’intero globo. Le responsabilità dei singoli cittadini che, sotto il ricatto del lavoro/reddito, sono in gran parte costretti a prendere l’auto per recarsi sul luogo di lavoro, non sono certamente paragonabili. Preso atto di ciò, la domanda che sorge spontanea è: perché la crisi (climatica) la devono pagare i poveri?
Il secondo aspetto riguarda l’eticità della lotta. Per spiegarmi meglio, ricorrerò ad un libro veramente potente per contenuti e narrazione: sto parlando del “Comitè Invisible” e dei suoi tre pamphlet: “L’insurrezione che viene”, “Ai nostri amici”, “Adesso” (da poco editi in Italia in un unico libro, per conto di NOT Nero Editions). Nel secondo libro “Ai nostri amici”, scritto nel 2014, riferendosi a delle rivolte scoppiate in Slovenia, il Comitè scrive ciò che a leggersi ora suona quasi come profetico:
Si può immaginare qualcosa di meno “politico” di una questione di autovelox come punto di partenza di un’insurrezione? Ma ci può essere qualcosa di più etico del rifiuto di farsi tosare come pecore? […] L’importanza del tema della corruzione, imperante in quasi tutte le rivolte contemporanee, attesta quanto queste siano etiche prima di essere politiche – oppure che sono politiche precisamente perché disprezzano la politica, compresa la politica radicale.


In una Francia divisa tra il neoliberismo Macroniano e la reazione razzista e xenofoba impersonata da Le Pen, il movimento dei Gilet ha avuto la capacità di inserirsi all’interno dello spazio politico, rigettando ambedue le visioni. Ha capito, in sostanza, che entrambe le formazioni sono due facce della stessa medaglia: l’una, con le sue politiche di austerità antipopolari, ha dato vita alle condizioni oggettive in cui l’altra potesse germogliare. I Gilet hanno compreso, a proprie spese, che al di là delle sfumature di linguaggio e degli orpelli politici, nessuno dei due schieramenti auspica minimamente di mettere in discussione il sistema economico, fatto di sfruttamento dell’uomo sull’uomo, e dell’uomo sull’ambiente.
Per distaccarsi totalmente, il movimento dei Gilet Jaunes si è avvalso, per usare termini giuridici, della facoltà di non rispondere: ha sempre rifiutato, in maniera marcatamente etica, qualsiasi tipo di dialettica nei confronti dall’apparato statale. Così facendo è stato in grado di proteggersi da critiche e tentativi di seduzione e strumentalizzazione da parte di ogni tipo di istituzione, volta nella pratica a reprimere o far rientrare la protesta, riuscendo al tempo stesso a far convergere al suo interno la composizione più disparata ed eterogenea. Ne da prova il fatto che, ad oggi, nessuno possa arrogarsi il diritto di autoproclamarsi leader della protesta.
Destra, Sinistra o qualsiasi sia la latitudine dalla quale la si guardi, che cos’è oggi la politica se non la gestione dell’esistente? Un esistente fatto di precarietà, sia essa lavorativa o esistenziale, di solitudine e sopraffazione: è quanto imposto dalla società, sempre più atomizzata.
Chi durante i riot, negli scontri di piazza, si sofferma sulla vetrina infranta e non sul legame che si crea tra chi ne prende parte, sta guardando il dito ignorando la luna. Soprattutto, non ha mai sperimentato l’emozione di potersi fidare ciecamente di un perfetto sconosciuto. L’ultima seduzione collettiva che ci è rimasta, capace di annullare la solitudine e distruggere la sopraffazione, non è forse proprio quella di spaccare tutto?
Il filosofo americano Noam Chomsky ha elaborato una teoria a riguardo, diventata famosa come “principio della rana bollita”, in relazione alla passività e rassegnazione di chi accetta vessazioni e soprusi senza mai ribellarsi:
“Immaginate un pentolone pieno d’acqua fredda nel quale nuota tranquillamente una rana. Il fuoco è acceso sotto la pentola, l’acqua si riscalda pian piano. Presto diventa tiepida. La rana la trova piuttosto gradevole e continua a nuotare. La temperatura sale. Adesso l’acqua è calda. Un po’ più di quanto la rana non apprezzi. Si stanca un po’, tuttavia non si spaventa. L’acqua adesso è davvero troppo calda. La rana la trova molto sgradevole, ma si è indebolita, non ha la forza di reagire. Allora sopporta e non fa nulla. Intanto la temperatura sale ancora, fino al momento in cui la rana finisce – semplicemente – morta bollita. Se la stessa rana fosse stata immersa direttamente nell’acqua a 50° avrebbe dato un forte colpo di zampa, sarebbe balzata subito fuori dal pentolone.”
Lo dimostrano le rivolte che stanno scoppiando in giro per il mondo, ad un ritmo irrefrenabile: dal Cile ad Hong Kong, passando per Francia ed Iran, il comun denominatore insito in ognuna delle proteste contemporanee sta proprio nel rifiuto dell’esistente, tout court. D’altronde, che cos’è una rivoluzione se non il rifiuto stesso dell’esistente?


Tuttavia, questo da solo non basta: l’odio che proviamo contro l’attuale modello di società che abbiamo, ormai istintivamente, identificato come ingiusto, si scontra con la totale mancanza di programmaticità ed organizzazione. Ciò, alla lunga, porta le ribellioni a “rientrare”, spesso implodendo, anziché tagliare completamente i ponti e “gettare il cuore oltre l’ostacolo”. Avviene a causa della repressione, o semplicemente, della concessione parziale di alcune rivendicazioni.
Il capitalismo continua a “vincere”, ancora oggi, non perché sia considerato come il “sistema” migliore, piuttosto perché è l’unico attualmente immaginabile dai più. Nell’epoca dell’Antropocene, “è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo”, sintetizzabile nel famoso motto Thatcheriano: “There is no alternative”.
Questo è il reale fulcro della questione, poiché se è vero che la rivoluzione parte con il rifiuto dell’esistente, è altrettanto vero che la sua messa in atto comincia il giorno dopo la destituzione della vecchia società. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, non siamo ancora in grado di immaginare andando oltre l’orizzonte imposto dal capitalismo, o comunque senza ricadere in dinamiche storicamente parallele, nella pratica altrettanto dannose. Per cambiare davvero qualcosa, bisognerebbe ammettere che, restando all’interno del sistema esistente, niente può essere davvero cambiato. Il compito di chi si pone come obiettivo quello di rivoluzionare lo stato di cose esistenti non può dunque limitarsi al proporre un nuovo modello parallelo, dovrebbe bensì puntare a cambiare radicalmente la prospettiva di ciò che appare possibile.
Ri-vivere gli spazi metropolitani più impensati, sperimentare nuovi modi di stare in piazza, costellare, senza timore, ogni muro di frasi e pensieri, persino sfondare le vetrine ed espropriare i negozi di alta moda lungo gli Champs-Élysées: un insieme di pratiche, completamente nuove per la maggior parte di chi le vive, fioriscono durante le sommosse, risvegliando le coscienze e permettendo di sperimentare una nuova umanità, che si riscopre nel totale rifiuto di un ordine precostituito.
Ogni rivolta, anche la più piccola e limitata, evidenzia l’esigenza di una nuova prospettiva di umanità. Sono i singoli uomini a dare vita alle rivolte, ma è nell’incontro e nel confluire collettivamente in ognuna di esse che si crea un nuovo sentire comune, che a sua volta dà vita ad un nuovo tipo di soggettività. In questo senso, ogni Evento in sé prefigura ciò che è il divenire: ad ognuno di noi spetta il compito di scegliere, di immaginare, di legare indissolubilmente il nostro esistente ad un altro tipo di esistenza, quella Collettiva.


Mors