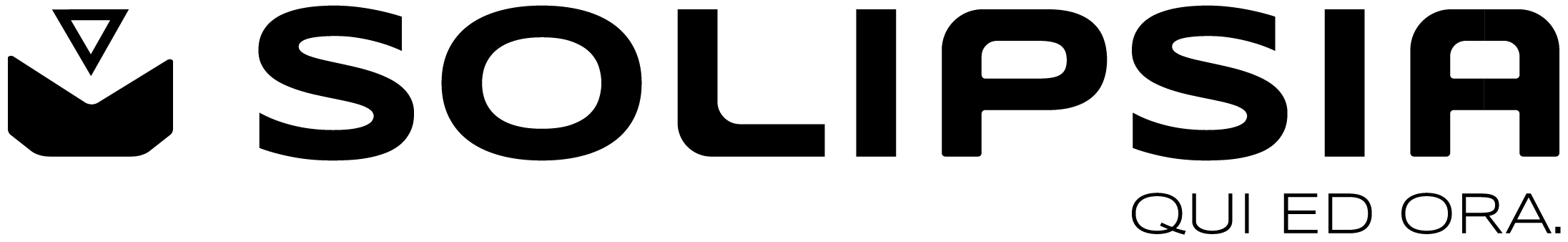Prima ancora di approdare su Solipsia, ho sempre avvertito dentro di me una voglia irrefrenabile di viaggiare, andare altrove per vedere cosa c’è oltre. Da quando vivo sull’isola è tutto più facile. Durante le belle giornate mi piace camminare verso il picco del monte e dirigo lo sguardo verso il basso, dove il pianeta si confonde sotto le nuvole. Così, scelgo la meta della prossima spedizione e poi mi reco all’astronave, collaudo tutto il necessario per il decollo e prendo il volo.
Non c’è un motivo ben preciso per cui io faccia tutto ciò, visto che sull’isola disponiamo del necessario per vivere sereni e spensierati. Tuttavia, continuo a sentire una spinta interna che mi porta ad esplorare, a vedere cose lontane che, solo poi, scopro essere così vicine. Sembra che tutto sia, in qualche modo, collegato in maniera invisibile.
Questa percezione aumenta in maniera esponenziale al di fuori della mia comfort zone, nella dimensione del viaggio appunto, quando mi ritrovo di fronte a qualcosa di nuovo, sconosciuto e diverso, ma allo stesso tempo semplicemente “bello”. Questo è il collante tra tutte le cose, ovvero la bellezza che le costituisce. La bellezza che c’è nelle cose mi fa sentire vivo e, da quando l’ho avvertita, non faccio altro che cercarla dappertutto.


Potrei commuovermi davanti ad un fiore, così come potrei estirparlo per fare m’ama o non m’ama, o potrei fare entrambe le cose: il Tutto è interdipendente con la sensibilità del Singolo che, nel caso dovesse rivelarsi estremamente acuta, può arrivare a sentire un tipo di bellezza non comunemente intesa e non comunemente rilevata. D’altro canto, però, lo stesso singolo potrebbe banalmente distruggerla, semplicemente non riconoscendola o, ancor peggio, cercando di appropriarsene o di strumentalizzarla. Ulteriormente, quando la bellezza viene trasformata in canone, si conforma, diventando una singola costruzione estetica, destinata esclusivamente agli standard “calati dall’alto” e, concretamente, avvizzendo nel tempo una volta “superata”. In questo caso, non mi sento più di parlare di sentimento, dato che la sensibilità rimane piatta: questa dimensione viene rimpiazzata da quella del Vedere, fine a se stesso. Il canone, lo stereotipo, sono le dimensioni più infime della bellezza. Una bellezza prima di tutto apparente, esteriore, quindi facile, oltre che superficiale e, di conseguenza, vuota. Semplificata all’osso fino alla mera apparenza fisica, ambita e rincorsa da tutti come strumento ed indicatore del proprio Status Sociale, diviene un bene di consumo acquistabile in una clinica, o in una palestra. Questa visione ha distolto la curiosità di andare a cercare la bellezza nelle cose “semplici”, creando l’illusione che sia tutto lì.
Tuttavia, la bellezza è altrove. Il mondo ne è pregno, ed è solo viaggiando che riesco a coglierla. Non perché non ne trovi ” in casa mia”, ma poiché talvolta ho bisogno di fare tanti chilometri per imparare ad apprezzare le cose più vicine. Non a caso credo che questo sentimento sia qualcosa di trasversale, sempre presente nel profondo di ognuno, ma silente e sornione, in attesa di essere colto.
Come si può pensare di descrivere un sentimento?


Non si può, a meno che quella descrizione non susciti dei ricordi emotivamente affini.
Vi porterò quindi con me, a bordo dell’astronave: in questo momento sto andando verso l’Europa. Sono alla ricerca di arte, la più alta ed umana manifestazione di bellezza: la dimensione artistica, più di tutte, rimarca il collegamento con quella sensoriale. Parcheggio il nostro fantascientifico mezzo di trasporto nei sobborghi periferici della città, evitando il traffico del centro. Precisamente mi trovo a Lubiana, capitale della Slovenia, una delle uniche due città di questa nazione che supera i trentamila abitanti. Tra le foreste più incontaminate del mondo, con una vegetazione che copre gran parte del territorio, sorge questo agglomerato, composto di strutture datate e moderne che convivono insieme.
Inizio a camminare verso il centro della città quando, dopo il ponte della stazione, mi imbatto in alcuni murales, vecchi come il muro decrepito sul quale sono disegnati. Attirato da questo intrigante miscuglio di degrado ed arte, decido di seguire il muro per qualche metro, finché mi imbatto in un cancello rosso, malridotto più delle mura stesse, ma semiaperto. Sento l’impulso di varcare le soglie di quel cancello, misto ad un’angosciante sensazione di abbandono. Spinto dalla curiosità fremente, decido di entrare e ricevo subito la conferma della bellezza che si cela tra quei ruderi.
Davanti a me si estende un’area all’apparenza degradata, dominata da una piazzetta centrale e circondata da un insieme di costruzioni in legno, tanto imponenti quanto fatiscenti. L’unico spazio privo di murales è l’asfalto su cui cammino. In giro spuntano strambe sculture: la mia attenzione viene rapita da una rete in gomma, dalla quale emergono sagome aliene; poco lontano scorgo un piede gigante, di pietra, con tanto di infradito. Improvvisamente mi sento preso da un’euforia irrefrenabile: ovunque posi il mio sguardo vedo arte. A volte nascosta in un cantuccio, altre volte quasi esposta, in mostra. In ogni caso, sempre sfacciata ed anticonformista.
Cammino, mi giro e mi rigiro, guardo sopra, poi in basso. Mi accorgo della vastità dell’area che, effettivamente, è più grande di un intero isolato.


Del resto, ha tutta l’aria di essere uno spazio indipendente: la scritta su un poster in lingua slovena recita “Metelkova Mesto”, che tradotto significa “Città di Metelkova”, e continua: centro culturale partigiano occupato presso le ex caserme austroungariche.
Tutte le opere che mi circondano assumono connotati storici precisi, intrisi di ribellione, di battaglie e sentimenti forti quanto utopici, rendendo il tutto ancora più emozionante. Il fatto che sia tutto così “disordinato” ed apparentemente abbandonato a se stesso fa sì che, dopo aver guardato un punto ben preciso per un paio di volte, ancora non si venga a capo di tutte le forme ed i colori che compongono quella minuscola sezione: tutto ciò stimola uno sguardo più attento e meno superficiale, come invece accade nei musei, dove l’ordine è, molto spesso, regola. In un luogo come questo, invece, non c’è spazio per una bellezza oggettiva: lo sguardo non è fine a se stesso, ma coinvolto emotivamente in quell’ammasso di arte che, privandosi di un canone, libera il sentimento in tutte le direzioni.
Mi siedo su una panchina per continuare la contemplazione quando, sollevando lo sguardo, mi imbatto in un bellissimo David malinconico, con lo sguardo rivolto in basso, appoggiato ad un finestrone e incorniciato da un muro fatiscente, decorato con un mosaico di piastrelle colorate. La visione mi appare di una bellezza sublime quanto tediosa, e sembra riassumere in un solo frame tutto quello che ho provato fino a quel momento: un senso di commozione estetica elevato, che si affianca ad una malinconia profonda. Un senso freudiano di Unheimlich mi pervade: è il fattore perturbante delle cose e la loro dimensione di bellezza insieme, in armonia.
Tuttavia, non posso fermarmi. Dunque, si riparte: lascio Lubiana, accendo la mia astronave dei ricordi ed imposto la nostra prossima meta, mentre mi lascio alle spalle la luce di Metelkova e dei suoi tesori nascosti. Mi porto dentro l’euforia dettata da quel fascino marginale, silenzioso, occultato in un angolo, in attesa di essere scovato: è la bellezza collaterale. Si nasconde perché teme di non essere capita, e spesso accade così, perché bisogna Sentire finemente per coglierla ed apprezzarla. Si cela lì, dietro ogni cosa, in agguato. Illumina tutto dal basso, perché dal basso proviene.


Come a La Habana, dove i bassifondi costituiscono gran parte della città e dove la città stessa si immedesima nei suoi bassifondi. Mi dirigo quindi nella parte più povera del nuovo continente, quella esclusa dal “sogno americano” e apparentemente dimenticata dalla logiche capitaliste. Mentre mi preparo ad atterrare, noto l’assenza di grattacieli o centri commerciali, che lasciano il posto ad una serie di palazzoni enormi, spesso diroccati, privati dal tempo degli strati di intonaco che prima ricoprivano i mattoni sottostanti, ora visibili. Camminando sulla grande via che costeggia l’oceano e conduce al centro della città, vedo queste strutture imponenti, simili a cantieri. Mi sorprendo nel vedere un’anziana signora sporgersi da uno di quei balconi fatiscenti, per stendere i panni su una corda di ferro (vista la mancanza della ringhiera).
Non c’è niente di bello nella povertà: è uno stato di tristezza, mancanze, sofferenza e rassegnazione che, tutt’oggi, logora gran parte del pianeta. Tuttavia, Cuba fornisce una prospettiva diversa. Mi addentro nelle reti urbane del centro (che, piuttosto, definirei una periferia più caotica). L’unica differenza sostanziale è la presenza del Capitolio, imponente palazzo che ospita il parlamento cubano, costruito sul modello del Campidoglio di Washington D.C, che (scontato dirlo) attira una gran mole di turisti. Decido di sorvolare e superare l’edificio, per poi esplorare i piccoli vicoli che compongono il cuore della vita di Havana. Passo in mezzo alla gente del popolo, riversata sulla calle: c’è un uomo che traina un carretto di legno vendendo frutta. Una signora anziana smercia le uova appena covate dalle sue galline, un’altra (un po’ meno anziana) mi chiede se posso comprare un po’ di latte per suo figlio. Bambini senza scarpe giocano a palla a muro, mentre una cadente macchina d’epoca li interrompe bruscamente con il clacson. Altri bambini si rincorrono con un bastone di legno, mentre da una casa si sentono note di chitarra. I vicoli del centro, abitati e vissuti attivamente dai locals, sono zone generalmente descritte come “da evitare”, poiché “pericolose” per chi le visita: basta poco per capire che, in realtà, non c’è nulla di cui temere. Nonostante qualche sguardo diffidente, la gente è cordiale e sorride al prossimo (invito a pensare a quanto questo possa sembrare scontato e quanto, in realtà, non lo sia per niente), apre le porte della propria casa. Ride, gioca, scherza, vive.
In altre parti del mondo, dove il benessere economico è dato per ovvio, molto spesso non si avverte questa vivacità, questa apertura, questa bellezza che si respira qui, nonostante tutte le difficoltà intrinseche. È significativo sottolineare quanto la concezione occidentale di Cuba sia sempre stata arbitraria: si tratta solamente di un contesto sociale e civile profondamente diverso da quello capitalista, ma è spesso evidente la paura diffusa ad esso correlata, nata dal giudizio preventivo provato nei confronti di questa (e qualsiasi altra) diversità.
Molte persone nel mondo parlano male di L’Avana, spesso ignorandone storia e cultura, visitandone soltanto le zone turistiche, di facciata, e descrivendola come una città decrepita e allo sbando, in cui i locali si fiondano come avvoltoi sui turisti per racimolare denaro. Sono le stesse persone che, solitamente, ne parlano vantandosi delle bellissime spiagge bianche, dell’ameno mare caraibico che bagna le coste e dei resort che frequentano ed in cui alloggiano durante le vacanze, spesso schivando e mantenendosi a distanza dalla vita, dalla popolazione e dalla bellezza reale del luogo.
Proseguo la mia passeggiata. Anche qui (come in Slovenia ed ovunque nel mondo) c’è una bellezza apparente, di facciata, ed un’altra molto più profonda, più difficile da cogliere, ma molto più redditizia in termini di emozioni. Girando per questa città mi sento immerso nella vita vera, la vita quotidiana di un popolo che lotta sì con la fame, ma continua a ridere. Mi sento immerso nella storia, scolpita in questi palazzi tanto sontuosi quanto decrepiti, testimoni, come detriti originali, di un passato ormai lontano.
Ecco la bellezza collaterale delle cose: una bellezza che emerge dal basso e illumina le parti più recondite e dimenticate, una bellezza che unisce tutta la malinconia e la tristezza presenti nel mondo e nella storia in un sentimento più grande, composto di solidarietà e partecipazione emotiva.


Tutto questo si può ritrovare, parallelamente, nell’estetica giapponese del Mono no aware, dove la partecipazione emotiva nei confronti della vita umana e della natura viene accompagnata da un senso di nostalgia dovuto al perenne mutamento. La traduzione in italiano è “sensibilità estetica delle cose”: un concetto che sembra interpretare appieno il sentimento di bellezza collaterale, di cui ho provato a raccontarvi. D’altronde, in una società deviata dai canoni, la soglia del Bello è sempre più bassa (moralmente), ma allo stesso tempo elevata perché ricercata nelle forme fisiche o nell’equivalente economico.
Tuttavia, la bellezza è qualcosa di più grande: è sentire che c’è ancora qualcosa in questo mondo, nel bene o nel male, che ci tiene uniti, nonostante i muri che continuano a volerci divisi e diffidenti.


T.Supertramp
(ph: T.Supertramp)