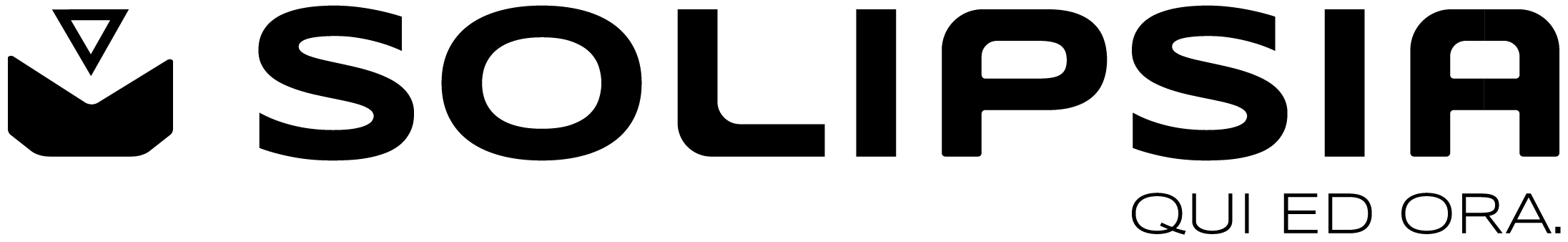La potenza di Facebook (e di altri social media) ha davvero contribuito in modo determinante alla formulazione di quel fenomeno che, attualmente, viene denominato “Hate Speech”? Oppure, semplicemente, i social media hanno reso visibile ciò che già esisteva al di fuori della rete? Ed inoltre, cosa si intende precisamente con l’espressione “hate speech”?
“Hate speech” (tradotto in italiano con “linguaggio d’odio” o “incitamento all’odio”) è un’espressione utilizzata per indicare quel genere di discorsi che hanno l’obiettivo principale di esprimere, per l’appunto, odio ed intolleranza verso una persona o un gruppo di persone. Sostanzialmente si tratta di un’offesa fondata su una discriminazione che può essere razziale, religiosa, di orientamento sessuale ecc.
Il quesito con cui ho deciso di iniziare questo saggio equivale a chiedersi, all’interno della società contemporanea, se sia nato prima l’uovo o la gallina. Una domanda difficile, la cui risposta è in qualche modo ibrida. Perché se è vero che un linguaggio discriminatorio nei confronti delle minoranze è stato presente, seppur in modo diversificato, in tutte le fasi della storia dell’umanità, è altrettanto vero che gli attuali mezzi di comunicazione (facebook, twitter ecc) hanno finito per amplificare, piuttosto che arginare, la diffusione di stereotipi, pregiudizi e false rappresentazioni della realtà all’interno della società.
Sicuramente il linguaggio d’odio razzista, misogino o omofobo era utilizzato e diffuso enormemente in vaste zone della società, in ambiti sia politici che privati, anche prima dell’avvento dei social media. Basti pensare alla moltitudine di studi affrontati su tale tema: ne è un esempio il celebre saggio, pubblicato nel 1991 da Philomena Essed, intitolato “Understanding Everyday Racism: An Interdisciplinary Theory”, nel quale l’autrice confronta il razzismo contemporaneo americano con il razzismo dei Paesi Bassi, attraverso una serie di interviste a donne di colore. Altro caso valido è rappresentato dagli studi di Teun Adrianus Van Dijk, linguista olandese, che ha cercato di esaminare le modalità attraverso cui le classi dirigenti al potere garantiscono il mantenimento di pregiudizi d’odio all’interno della società. Attraverso i suoi studi, Van Dijk sottolinea come gli individui abbiano possibilità di intervenire attivamente solamente all’interno delle conversazioni quotidiane che avvengono tra i membri della propria famiglia o con i propri amici: nel restante tempo, quegli stessi individui non fanno che ascoltare passivamente i discorsi trasmessi dalla televisione o pronunciati da un qualche politico.
Dunque, gli stereotipi e i pregiudizi si diffondono principalmente attraverso quei canali di comunicazione che non prevedono un feedback paritario con gli ascoltatori, i quali ricevono passivamente il messaggio. In questo modo prende forma, progressivamente, una cornice ideologica persuasiva, costituita da alcuni elementi fondamentali: diversità, minaccia, invasione, problema, soluzione. Questa dinamica finisce per condizionare, anche inconsapevolmente, le convinzioni di ciascun individuo.


Si genera così una sorta di «dimensione collettiva del rancore», utilizzando l’espressione di Giovanni de Luna, molto difficile da controllare. Nell’ultimo decennio, infatti, le istituzioni, che avrebbero in teoria il compito di arginare la diffusione di espressioni d’odio all’interno della società, si sono rese, piuttosto, un megafono di false rappresentazioni della realtà, finendo per fare leva, attraverso la ripetizione ossessiva di slogan sempre uguali, sulla cosiddetta “pancia del paese”.
Questa rottura tra registri di comunicazione alti e bassi, tra pubblico e privato, ha provocato una proliferazione dei discorsi d’odio. Tale proliferazione, nel corso del tempo, ha reso gli individui abituati non solo a produrre discriminazione, violenza e razzismo linguistico (e non), ma anche a leggerne o ascoltarne rivendicazioni tranquillamente in televisione. Dunque, appare ormai normale alla maggior parte delle persone che un politico o un qualsiasi personaggio pubblico possa pronunciare, liberamente, discorsi di incitamento all’odio e all’intolleranza, difeso dallo scudo della libertà di espressione.
La commissione parlamentare “Jo Cox” sui fenomeni di odio, intolleranza, xenofobia e razzismo, studiando approfonditamente il fenomeno Hate Speech, ha utilizzato la metafora della “piramide dell’odio”, per far comprendere maggiormente la complessità del fenomeno. La base di tale piramide sarebbe formata da un campionario di stereotipi radicati nei secoli e, quindi, facilmente “riattivabili” all’interno della società. Il livello successivo è quello della discriminazione che, presa consapevolezza dell’alterità, legittimerebbe la verbalizzazione di linguaggi d’odio. La cima della piramide, invece, è costituita da crimini d’odio veri e propri, cioè atti di violenza fisica perpetrati contro individui per qualsiasi diversità, solitamente preceduti da epiteti offensivi.


C’è dunque una relazione immanente tra il linguaggio razzista e il conseguente comportamento razzista.
L’Hate Speech, diffuso nei social media, non fa che provocare un incremento di episodi di razzismo all’interno della società. La rete, dunque, non fa altro che amplificare un fenomeno che le istituzioni dei vari paesi dovrebbero preoccuparsi di arginare, ma che nella realtà dei fatti alimentano. Ad esempio, la mozione per istituire una commissione straordinaria contro odio, razzismo e antisemitismo, proposta dalla senatrice Liliana Segre, non ha ricevuto l’unanimità in senato (151 voti favorevoli e 98 astenuti). L’approvazione con voto unanime di tale mozione avrebbe potuto costituire una presa di posizione molto forte, nonché un importante messaggio simbolico rivolto ad ogni singolo individuo. Ancora una volta, tuttavia, non è stato così.
I social network non si configurano come luogo d’origine dell’hate speech, ma, piuttosto, il mezzo attraverso cui un linguaggio discriminatorio, da secoli diffuso all’interno della società, ha ricevuto maggiore risonanza e potenza. L’utente medio, all’interno della realtà irreale dei social, ha la possibilità di diffondere con estrema facilità opinioni fortemente polarizzate, impermeabili a qualsiasi possibilità di confronto, senza preoccuparsi del proprio analfabetismo funzionale e della propria disinformazione. Tutti hanno la possibilità di parlare, esprimere giudizi, senza alcun filtro o limite, in pochissimi caratteri, attraverso slogan che possono condizionare un qualsiasi altro utente presente in rete. Attualmente, questo meccanismo, seppur semplice e facile da individuare, rappresenta un grave problema sociale, in grado di aumentare l’incomunicabilità che spesso intercorre tra le diversità presenti in una comunità.
La reazione all’enorme diffusione dell’Hate Speech da parte delle grandi aziende di internet (come Google, Facebook, Youtube ecc.) è ancora piuttosto ambigua. Nonostante negli ultimi due anni siano stati posti degli standard ristrettivi al fine di arginare tale fenomeno, spesso tali standard non sono rispettati o risultano, nella gran parte dei casi, insufficienti.
Ad esempio, secondo gli studi svolti dall’associazione Carta di Roma (un’associazione fondata con l’obiettivo di dare attuazione al protocollo deontologico per un’informazione corretta sui temi dell’immigrazione), solamente un terzo dei contenuti segnatati sarebbero stati effettivamente eliminati da Facebook. I restati due terzi delle segnalazioni hanno ricevuto la solita risposta automatica:


Nonostante il Code of Conduct on Countering Illegal Hate Speech Online (del maggio 2016) sottoscritto da Facebook, Twitter, Youtube e Microsoft (che sono stati costretti a rispettare norme europee più stringenti volte a rimuovere la maggior parte dei messaggi illegali di incitamento all’odio), il problema non è ancora stato risolto. L’Hate Speech, come risulta evidente osservando i contenuti postati nei social, non solo non è stato eliminato, ma ha pervaso praticamente tutti i registri linguistici, provocando un fastidioso rumore di fondo onnipresente.
Internet è uno spazio indefinito, transnazionale, senza confini. Proprio in virtù della sua stessa essenza, non può essere controllato efficacemente in base alle normative di un singolo stato.
A livello burocratico ed istituzionale, sarebbe necessario elaborare un confronto su base internazionale, al fine di promuovere delle iniziative e normative uniformi, con l’obiettivo di ostacolare concretamente la diffusione di contenuti offensivi contro ogni tipo di minoranza, oltre che promuovere attività di sensibilizzazione, volte a diffondere una cultura di equità, diritti e rispetto per l’altro.
In tal contesto, l’ostacolo più difficile da superare per affrontare concretamente il fenomeno dell’Hate Speech (oltre che il più dibattuto) consiste nel precario equilibrio che viene ad instaurarsi tra lo stesso fenomeno e l’inalienabile diritto alla libertà di parola, principio tutelato e fondante di ogni presunta democrazia (o almeno così dovrebbe essere). È importante, però, sottolineare come la libertà, in quanto tale, non è mai assoluta, ma sempre in relazione all’altro, chiunque esso sia. Il linguaggio d’odio, in questo senso, colpisce la dignità dell’individuo e la sua libertà di essere senza limitazioni, minacce o discriminazioni. In nessun caso il diritto alla libertà d’espressione può essere utilizzato per legittimare la volontà di privare gli altri individui della libertà di essere sé stessi.
Libertà significa avere la totale possibilità di raggiungere, secondo i propri desideri e le proprie inclinazioni, quello che riteniamo essere il nostro personale benessere, senza privare o ostacolare in alcun modo gli altri nel raggiungimento del proprio. In quanto tale, è un concetto che si realizza solo quando appartiene a tutti. Non si può costringere un individuo a fare qualcosa, persino se si ritiene che possa arrecare un beneficio per la sua persona, se l’individuo stesso non lo desidera. La costrizione, intesa come impedimento, è giustificata unicamente se l’azione da cui si desidera distogliere l’individuo sta recando danno a qualcun altro. Come sostenuto da John Stuart Mill in “On liberty” (aldilà delle sue varie inclinazioni, interpretazioni e strumentalizzazioni, politiche o statali che siano) «il solo aspetto della propria condotta di cui ciascuno deve rendere conto alla società è quello riguardante gli altri: per l’aspetto che riguarda soltanto lui, la sua indipendenza è, di diritto, assoluta. Su sé stesso, sulla sua mente e sul suo corpo, l’individuo è sovrano».
Dunque se la libertà, in quanto tale, non può essere assoluta (quindi assolutista), è necessario che in qualsiasi caso sia posto un limite, unico, al singolo individuo, che sia però intrasgredibile: non recare danno all’altro, chiunque l’altro sia.


Prix
(ph: T. Supertramp)