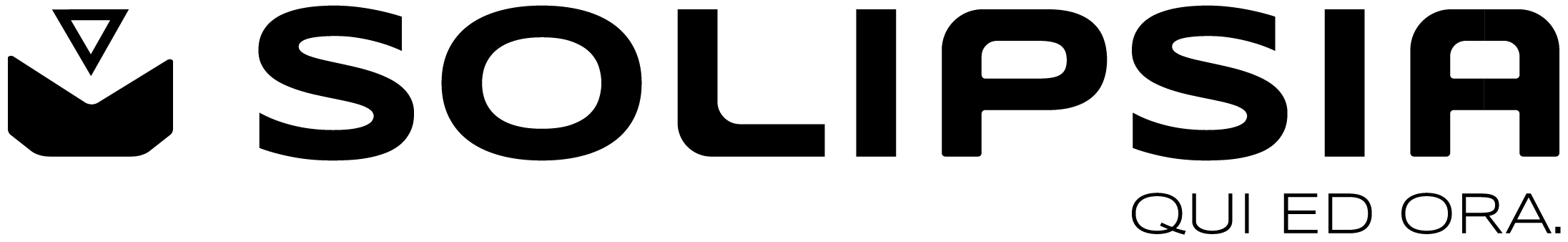“CONVERSAZIONI SULL’ABITARE”, CON ANDREA STAID E MATTEO MESCHIARI
Cosa rappresenta per l’essere umano abitare uno spazio? Più precisamente, cosa significa sentirsi a casa? In un periodo di grave emergenza abitativa che investe non solo Bologna, ma anche altre città italiane, che importanza assume l’autocostruzione e il “saper fare” nell’esistenza di ciascun individuo?
Riflettere sul significato che assume, per l’essere umano, abitare uno spazio è stato l’obiettivo centrale dell’incontro organizzato venerdì 4 ottobre dal Laboratorio L’Isola, con gli antropologi Matteo Meschiari e Andrea Staid e l’architetto Maurizio Corrado. Solipsia ha deciso di partecipare con piacevole interesse, vista l’importanza dell’argomento.
Durante l’incontro, Matteo Meschiari, autore di “Disabitare: Antropologia dello spazio domestico”, e Andrea Staid, autore di “Abitare illegale: Etnografia del vivere ai margini in Occidente”, hanno innanzitutto sottolineato come abitare uno spazio rappresenti uno dei bisogni primari dell’essere umano, in quanto strettamente collegato alla sua autodeterminazione, cioè alla possibilità e alla capacità di fare delle scelte significative in via autonoma ed indipendente, al fine di riconoscersi nel tipo di vita che si desidera, in linea con le proprie inclinazioni.
In una situazione di emergenza abitativa diffusa, sgomberi e affitti troppo cari, l’antropologia può rappresentare uno strumento utile per riflettere sul presente. Tale disciplina, infatti, analizzando situazioni lontane della nostra esperienza, è in grado di raccogliere informazioni che finiscono per avere una ricaduta critica sulle nostre convinzioni. L’antropologia racconta una narrazione diversa dall’ordinario e tale narrazione, nel momento in cui viene messa a confronto con i paradigmi della nostra cultura, assume una forza critica di eccezionale importanza. Infatti, analizzare una serie di problematiche contemporanee, mettendole a confronto con l’antropologia dell’abitare di popoli con caratteristiche differenti rispetto alle nostre, consente di trovare delle coordinate essenziali, che ci suggeriscono un ripensamento delle nostre priorità.
Conversare sull’abitare umano in un luogo come Il Laboratorio L’isola, situato nella periferia di Bologna, in un luogo sospeso tra campagna e città, rappresenta metaforicamente una spaccatura all’interno di un sistema che ci imprigiona in piccoli appartamenti mononucleari, laddove per millenni l’essere umano ha vissuto tra praterie e foreste. Come evidenziato da Meschiari, anche analizzare un periodo storico lontano dal nostro, come ad esempio la preistoria, consente di comprendere come l’uomo, costitutivamente legato agli spazi aperti, abbia finito per rinchiudersi in piccoli appartamenti, imprigionato all’interno di quattro mura, dietro lo schermo di uno smartphone e sostanzialmente solo.
Il concetto di ciò che noi oggi intendiamo con il termine “casa” ha una data di nascita ben precisa: il neolitico.
Fino a 10.000 anni fa, la casa non esisteva. L’attività principale dell’homo sapiens era la caccia e, dunque, non era necessaria una dimora fissa: si era principalmente nomadi. Nel momento in cui l’homo sapiens è diventato agricoltore e allevatore è stato necessario fermarsi e, progressivamente, sono stati formulati i concetti di muro, confine, proprietà privata. L’agricoltura ha permesso l’ottenimento di un surplus alimentare, che è stato necessario conservare in un luogo che assumeva questa funzione. Dunque, è a partire dal neolitico (circa 10.000 anni fa) che si sono gettate le fondamenta di un’idea di abitare che oggi mettiamo in atto continuamente. In questo senso, la casa può essere considerata un’epopea di architettura vernacolare: un’architettura spontanea, che riguarda forme di abitazione che appartengono alla tradizione più antica dell’uomo (tende, portici, capanne).


Andrea Staid, durante l’incontro, ha deciso di raccontare la sua esperienza diretta in Vietnam del Nord, Mongolia e Thailandia, a stretto contatto con le comunità del luogo. L’antropologo, spiegando le modalità attraverso cui ha deciso di intraprendere la sua analisi, ha sottolineato come, al fine di raccogliere delle informazioni riguardo le modalità di abitazione del luogo, abbia prima mostrato alla comunità delle foto raffiguranti la propria abitazione. Andrea ci ha raccontato di un suo incontro in particolare con una donna che, dopo aver osservato la foto di una porta blindata (quindi un oggetto lontano dall’esperienza per una comunità che autocostruisce le proprie abitazioni), gli chiese a che cosa servisse. A questo punto, Staid rispose alla donna che la foto rappresentava il tipo di porta che, nelle nostre abitazioni, viene chiusa nel momento in cui andiamo a dormire per sentirci al sicuro. La donna allora chiese ulteriormente:
«Voi vi chiedete dentro casa quando andate a dormire? Non avete paura?»
La domanda della donna risulta di particolare importanza per comprendere come una comunità, lontana dalla realtà che viviamo quotidianamente, abbia un’idea di sicurezza opposta alla nostra. Per la realtà con cui l’antropologo si è confrontato, la sicurezza è rappresentata da una porta che si può aprire in qualsiasi momento (anche dall’esterno): al contrario, il chiudersi a chiave dall’interno, nella propria abitazione, genera negli abitanti una sensazione di ansia e angoscia. La sicurezza, in questo contesto, significa riconoscersi nei diversi soggetti della comunità e, quindi, non averne paura. La dimensione collettiva, infatti, è parte costituente dell’identità di quella determinata comunità e assume un’importanza fondamentale all’interno della stessa.
È evidente, dunque, come il nostro modo di vivere risulti “strano” e relativo, nel momento in cui viene messo a confronto con l’alterità. Infatti, diversamente dalle realtà con cui è entrato in contatto Andrea Staid, noi viviamo in appartamenti mononucleari, chiusi dentro le nostre mura, dove l’unico spazio condiviso è rappresentato dal piccolo giardino condominiale, in cui è vietato fare qualsiasi cosa: parcheggiare, giocare, passeggiare, organizzare una festa.
Anche negli Stati Uniti, nonostante viga un modello di civiltà occidentale, l’idea di casa è molto diversa da quella europea.
Come sottolineato da Meschiari, la vera ossessione americana è domestica: tutte le cose che terrorizzano di più l’individuo hanno a che fare con lo spazio domestico. Basti pensare ai film americani: quando si deve rappresentare il nemico, esso viene rappresentato in cantina, in soffitta, dentro l’armadio. La porta dell’abitazione, soprattutto nelle periferie americane, viene lasciata aperta affinché sia possibile una circolazione di bene e male. Dunque la casa, per la mentalità americana, non rappresenta il luogo in cui è possibile sentirsi al sicuro poiché i mostri, i nemici, sono all’interno dello spazio domestico.
È chiaro, dunque, che alla domanda «che cos’è casa?» non può esserci una risposta univoca e universale.
La radice etimologica del termine “abitare” ci suggerisce che questo concetto ha a che fare con le nostre abitudini, i nostri abiti e, quindi, con noi stessi. La casa ci costituisce a livello identitario, non è la semplice costruzione in mura che ci protegge dall’esterno, non è semplicemente house: la casa rappresenta noi stessi, è home, la si abita prima di tutto con la propria mente. Casa non è solamente quella che compriamo o affittiamo, non è una merce, ma rappresenta il luogo in cui costruiamo la nostra identità attraverso la creazione delle relazioni sociali che ci costituiscono. Per secoli, l’essere umano ha costruito la propria abitazione con le proprie mani: questa autocostruzione entrava in relazione con la costruzione identitaria dell’individuo e della sua comunità. Da due secoli abbiamo delegato la capacità di costruire la nostra abitazione a qualcun altro. Da homo faber siamo diventati homo confort.
Come sottolineato dai due antropologi, è a partire dal confronto con realtà diverse da quelle di cui abbiamo esperienza quotidianamente che abbiamo la possibilità di elaborare un’alternativa ad una situazione interna sempre più soffocante. La popolazione mondiale, infatti, continua a crescere: nel 1927 eravamo 2 miliardi, alla fine degli anni ’90 del Novecento eravamo 6 miliardi, adesso siamo circa 7,7 miliardi di persone. Gli studi e le proiezioni elaborate dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (DESA) mostrano come, probabilmente, nel 2050 ci saranno 9,7 miliardi di persone e, nel 2100, diverranno circa 11 miliardi.
In una situazione di sovrappopolazione mondiale, che ha determinato una contrazione dello spazio disponibile, è stato necessario ripensare lo spazio domestico.
Tutto è stato parcellizzato e ridotto al minimo: basti pensare alle Tiny House o ai grattacieli che, sviluppandosi in altezza, sono in grado di contenere centinaia di appartamenti. Inoltre, le città e le megalopoli occidentali sono continuamente dominate e sottomesse da processi di gentrificazione, gestiti dall’alto e attuati attraverso sgomberi, oltre che tramite l’eufemismo della «riqualificazione estetica».


Il fenomeno della gentrificazione consiste in un radicale mutamento delle aree periferiche delle città sia a livello ambientale (attraverso la demolizione di edifici considerati “degradanti” e la ricostruzione degli stessi), sia a livello di composizione sociale. Questo fenomeno genera chiaramente un’opportunità di profitto per il capitale privato, interessato ad avviare processi di riqualificazione delle zone più attrattive, con il conseguente aumento del prezzo degli immobili. Nel momento in cui avviene questo miglioramento urbano, nuovi abitanti ad alto reddito tendono ad affluire. I vecchi abitati, caratterizzati solitamente da un reddito più basso, sono costretti a trasferirsi poiché non hanno più la possibilità di risiedervi. Tutto ciò provoca, di fatto, la materializzazione spaziale della polarizzazione sociale e l’aumento del divario che intercorre tra le classi abbienti e le classi più povere, esito più evidente dei processi di globalizzazione.
Come affermato da Murray Bookchin:
«Per recuperare l’urbanesimo come il terreno adatto all’associazionismo, alla cultura, alla comunità, la megalopoli deve essere distrutta e sostituita da comunità decentrate, inserite con cura all’interno dell’ecosistema di cui fa parte»
Come sottolineato da Andrea Staid, i comitati e le assemblee dei quartieri popolari che organizzano manifestazioni per il diritto all’abitare sono realtà dove si mettono in pratica dinamiche di autogestione e autogoverno, in grado di elaborare soluzioni concrete per donne e uomini che non hanno abbastanza reddito per vivere dignitosamente nel sistema vigente. In questo senso, le periferie della città e i margini sociali rappresentano realtà utili per criticare un centro sempre più sottomesso da un capitalismo sfrenato e in balia di un processo di gentrificazione voluto dall’alto. Lo spazio ha, per sua natura, una certa permeabilità alle dinamiche di potere. È il potere che, dall’alto, stabilisce le norme che vietano di vivere liberamente quegli spazi in cui sarebbe possibile praticare una vita collettiva, in favore di quell’individualismo sterile che ci appartiene sempre di più. Basti pensare alle piazze delle diverse città italiane, dove non è più possibile sedersi per terra. Si pensi ai giardini condominiali in cui i bambini, in gran parte dei casi, non possono giocare liberamente, oppure ai tavoli dei bar che occupano la maggior parte dello spazio collettivo.
La funzione degli spazi pubblici, cioè l’incontro tra i diversi individui, viene eliminata in nome del decoro o della «riqualificazione estetica».
Come affermato da David Graeber nel libro “Burocrazia“ (2016), il problema della burocrazia, cioè della creazione di norme imposte dall’alto, non risiede solo nel fatto che tali norme vietino di fare qualcosa, ma più che altro nella cristallizzazione all’interno delle menti delle persone che quella cosa non si può più fare. Se ad esempio, nel momento in cui viene stabilito che non è più possibile sedersi in mezzo alla piazza perché non consono al decoro della città, noi rispettiamo la regola per paura della multa, dopo poco tempo smetteremo totalmente di pensare di voler sederci in piazza.
Come sottolineato da Matteo Meschiari, immaginare il futuro ed elaborare delle soluzioni alla situazione presente è qualcosa di molto complesso, perché implica l’analisi di molteplici variabili che non è sempre possibile avere a disposizione. Inoltre, il progressivo collasso del sistema Terra, dovuto al cambiamento climatico di cui siamo testimoni, ci sta privando della possibilità di immaginare un futuro lontano e, quindi, anche un’alternativa funzionale al presente. In questo senso, l’antropologia si rivela uno strumento utile al fine di individuare delle alternative ibride, in grado di unire “l’altrove“ con il “qui”.
Confrontarsi con realtà lontane (come le comunità del Vietnam) o, semplicemente, diverse da quelle di cui abbiamo esperienza quotidianamente (come associazioni autogestite e comitati) è un modo utile per scardinare i modelli mentali che affollano le nostre menti, di cui non siamo ancora totalmente consapevoli. Realtà di questo tipo sono in grado di spaccare la città, ridefinendone la fisionomia: ci ricordano che, infondo, siamo individui liberi.
Come Calvino scriveva ne “Le città invisibili”
«Ogni città riceve la forma dal deserto a cui si oppone»


Prix
(ph: T. Supertramp)